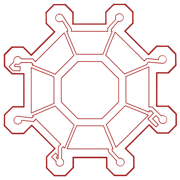Il testo ancora attuale della relazione di Alain de Benoist, invitato ad una conferenza sul federalismo, tenutasi nel 2005. Buona lettura!
Mi è stato chiesto di venire a esporvi quali sono i principi essenziali del federalismo. Credo che il modo migliore per soddisfare questa richiesta sia definire fin dal principio ciò che è più fondamentalmente opposto al federalismo, cioè l’ideologia giacobina.
Il giacobinismo corrisponde storicamente alla forma più estrema dell’ideologia dello Stato moderno, cioè dello Stato-nazione. È un’ideologia che mira a riunire in modo rigoroso, a rendere omotetica su uno stesso territorio, l’unità politica, culturale, linguistica o etnica, grazie all’azione di un potere centrale detentore di una sovranità esclusiva, supporto visibile dell’interesse di tutti e rappresentante unico dell’insieme dei cittadini. Questa volontà di unità porta a considerare come sinonimi lo Stato e la nazione, la cittadinanza e la nazionalità. Sebbene il termine «giacobinismo» alluda ovviamente all’azione svolta durante la Rivoluzione francese dal Club dei Giacobini, il concetto a cui corrisponde è molto più antico. Apparve durante l’Ancien Régime, in particolare all’inizio del XVI secolo, con Jean Bodin (1520-1596), che teorizzò una nuova teoria della sovranità. Mentre nel Medioevo l’organo sovrano rappresentava solo quello con la più ampia competenza, quello a cui apparteneva il potere decisionale ultimo, la sovranità è definita in Jean Bodin come la capacità del principe di essere al di sopra della legge positiva (legibus solutus), di averne il monopolio e di disporne a proprio piacimento. Questa concezione si ispira all’assolutismo papale (e quindi al modello dell’onnipotenza divina), e va di pari passo con la diffusione del diritto romano a scapito del diritto consuetudinario. Si tratta di una nuova teoria della rappresentanza politica, che d’ora in poi agirà come fattore di unità e di omogeneità. Il principe, lungi dall’essere un delegato o un esecutore, riassume in sé tutti gli organi intermedi. Sovrano e rappresentante sono la stessa cosa, perché lo Stato incarna tutti i membri della società. Al pluralismo medievale, caratterizzato dall’intreccio di alleanze e dalla dispersione delle sovranità, subentra poi un blocco monolitico che si riassume nella persona e nel corpo del re. Da quel momento in poi, i gruppi sociali non sono altro che organi passivi della Repubblica. La concezione bodiniana della sovranità pone le basi per l’assolutismo e diventerà gradualmente sinonimo di potere illimitato. Il sovrano, infatti, non solo non è vincolato alla reciprocità del contratto, non avendolo sottoscritto egli stesso, ma, traendo il suo potere dalla volontà razionale di tutti, ha anche diritto di esigere da tutti l’obbedienza totale. Poiché la sua legittimità deriva dal fatto che gli altri membri hanno volontariamente abdicato alla loro sovranità a suo vantaggio, non dipende da nessuno ed è quindi al di sopra dei diritti e delle leggi. Il popolo, infine, non può gli si può opporre, perché non dovendo nulla ad alcuno, egli non può essere privato della sua autorità. Meglio ancora, il principe è l’unico la cui libertà illimitata deriva dallo stato di natura in cui è rimasto e quindi la sua sovranità è anche indivisibile e assoluta. È posto come fondamento unitario ed è identificato con lo Stato, quindi qualsiasi distribuzione o frammentazione del potere viene interpretata come causa di instabilità e divisione politica.
Nel 1789, la Rivoluzione francese diede per la prima volta un significato politico all’idea di Nazione abolendo gli ordini dell’Ancien Régime, ma mantenne, peggiorandola, la stessa tendenza al centralismo, la stessa concezione di sovranità. Trasferisce solamente alla Nazione le prerogative del principe e l’unità indivisibile che ai tempi della monarchia assoluta veniva attribuita alla persona del re. L’ossessione per l’unità è più forte che mai. Saint-Just e Robespierre non smetteranno mai di ripetere che «l’unità è la nostra massima fondamentale, l’unità è la nostra difesa antifederalista, l’unità è la nostra salvezza». L’idea di Nazione, considerata come unitaria e trascendente e la cui unità e indivisibilità sono necessariamente indipendenti da ogni principio esterno, finisce poi per coprire la nozione di popolo fino a sostituirla, inaugurando una tradizione che il diritto pubblico in molti Paesi ha continuato a perpetuare da allora. Infine, la concezione rivoluzionaria della sovranità fa di nazionalità e cittadinanza due sinonimi: non c’è più un membro della Nazione che non sia cittadino (salvo i casi in cui non sia privato dei suoi diritti civili) né un cittadino che non sia membro della Nazione. Il popolo è tanto più «indivisibile e unitario» in quanto è diventato una semplice astrazione. Per questo la Francia, ancora oggi, non è uno Stato federale e non può riconoscere l’esistenza di un popolo corso o bretone. Così, sotto la Rivoluzione, allo stesso modo di come si pensava durante l’Ancien Régime, troviamo una concezione della sovranità come di un «potere assoluto ed eterno» della Repubblica, fonte di tutti i diritti e doveri del cittadino. La sovranità dei giacobini non prevedeva più restrizioni di quella di Jean Bodin. I rivoluzionari denunciano il «federalismo» negli stessi termini che usava la monarchia assoluta quando rimproverava, ad esempio, ai protestanti di voler «cantonizzare» la Francia sull’esempio della Svizzera. Si anatemizzano e si combattono i particolarismi locali nello stesso modo in cui il potere reale si sforzava con tutti i mezzi di ridurre l’autonomia dei signori feudali. Per legittimare la giustizia rivoluzionaria, vengono proposti gli stessi argomenti che Richelieu utilizzava per difendere il potere discrezionale del principe. Con la Rivoluzione, la sovranità nazionale si oppose all’assolutismo reale, non affatto però rinnegando l’assolutismo, ma trasferendo le prerogative assolute del re alla Nazione. La Nazione politica esige una rappresentanza unica (un’unica assemblea deve rappresentare tutti i cittadini), ciò significa che non può esserci una legge particolare applicabile a un gruppo specifico; ci sono solo leggi generali, che si applicano a tutti gli individui indipendentemente dai loro caratteri specifici. La Nazione allora si identifica, non più con il popolo o con la società, ma con lo Stato. È costituito da esso, e allo stesso tempo egli coincide con essa. Il moderno principio di cittadinanza trascura quindi la lingua, la cultura, il credo, il genere, ecc., cioè tutto ciò che rende le persone come sono e non altrimenti. Si basa sull’«uguaglianza» degli individui rispetto al solo sistema politico, tutto ciò per cui differiscono viene portato nella sfera privata. Le differenze culturali e le identità collettive considerate contingenti, minori, persino illusorie, sono ritenute politicamente insignificanti. Sono tollerate solo a condizione che siano invisibili o inefficaci nella sfera pubblica. La dottrina ufficiale è ora quella dell’assimilazione, cioè quella dell’eradicazione-digestione: l’Altro deve diventare il Medesimo. La modernità politica rigetta gli elementi etnici e culturali dalla sfera politica e consente loro di esistere solo nella società civile. Allo stesso tempo, le minoranze si trovano private di qualsiasi status politico. Questo è il motivo per cui la generalizzazione del principio dello Stato-nazione si tradurrà ovunque nell’oppressione delle minoranze. È esattamente proprio a questa concezione che si oppone il federalismo, le cui fondamenta sono il principio di sussidiarietà (o di sufficiente competenza), sovranità condivisa, democrazia diretta, riconoscimento di organismi intermedi, identità collettive e le comunità.
*
Il sistema federalista si caratterizza come un sistema di unità politiche strettamente intrecciate, solidali e reciprocamente stimolanti. Il federalismo è infatti l’unico sistema in cui il governo centrale condivide i vari poteri costituzionali e legislativi con le comunità sulle quali ha autorità, assicurando che tali poteri siano esercitati al livello più basso possibile. I suoi tre principi fondamentali sono l’autonomia, la partecipazione e la sussidiarietà. L’autonomia consente a ciascuna comunità di mantenere la massima libertà di azione. La partecipazione consente a ogni livello di collaborare al processo decisionale. La sussidiarietà consente sempre di esercitare la presunzione di competenza a favore del livello più vicino agli interessati.
Questo sistema implica una concezione della sovranità che è l’antitesi di quella di Jean Bodin. Questa concezione è quella che si trova esposta, proprio all’inizio del XVII secolo, da Johannes Althusius nella sua opera principale, la Politica methodice digesta (1603). Avversario di Bodin, Althusius (1557-1638) parte da Aristotele per descrivere l’uomo come un essere sociale, naturalmente incline alla mutua solidarietà e reciprocità (ciò che lui chiama la comunicazione di beni, servizi e diritti). La scienza politica per lui consiste nel descrivere metodicamente le condizioni della vita sociale, da cui il termine «simbiotico», che usa per caratterizzare il suo approccio. Rifiutando l’idea che un individuo sia sufficiente per sé stesso, afferma che la società viene sempre prima rispetto ai suoi membri (o «simbionti»), e che è costituita da una serie di patti politici e sociali conclusi dalla base, attraverso una moltitudine di associazioni (o «consociazioni») autonome, naturali e istituzionali, pubbliche e private: famiglie e nuclei familiari, corporazioni e corpi intermedi, comunità civili e collegi secolari, città e province, ecc. Queste «consociazioni» si incastrano in un ordine che va dalla unità più semplice alla più complessa. Gli individui collaborano ad ogni livello, non come singoli atomi, ma come membri di una comunità già esistente, che non rinuncia mai a tutti i suoi diritti a beneficio di una società più ampia. Althusius dà così alla nozione di rappresentanza un significato totalmente diverso da quello che troviamo nel pensiero contrattualista liberale: il contratto sociale non è per lui un atto unico risultante dal libero gioco delle volontà individuali, ma una «alleanza» (foedus) che si integra in un processo continuo di comunicazione «simbiotica» tra individui definiti soprattutto dalla loro appartenenza. Il federalismo è infatti l’unico sistema in cui il governo centrale condivide i vari poteri costituzionali e legislativi con le comunità sulle quali ha autorità, assicurando che tali poteri siano esercitati al livello più basso possibile. I suoi tre principi fondamentali sono l’autonomia, la partecipazione e la sussidiarietà. L’autonomia consente a ciascuna comunità di mantenere la massima libertà di azione; la partecipazione permette a ogni livello di collaborare al processo decisionale; la sussidiarietà consente sempre di esercitare la presunzione di competenza a favore del livello più vicino agli interessati. Questo sistema implica una concezione della sovranità che è l’antitesi di quella di Jean Bodin. Questa concezione è quella che si trova esposta, proprio all’inizio del XVII secolo, da Johannes Althusius nella sua opera principale, la Politica methodice digesta (1603). Avversario di Bodin, Althusius (1557-1638) si affida ad Aristotele per descrivere l’uomo come un essere sociale, naturalmente incline alla mutua solidarietà e reciprocità (ciò che lui chiama la comunicazione di beni, servizi e diritti). La scienza politica per lui consiste nel descrivere metodicamente le condizioni della vita sociale, da cui il nome “simbiotico” che usa per caratterizzare il suo approccio. Rifiutando l’idea che un individuo sia sufficiente per sé stesso, afferma che la società viene sempre prima rispetto ai suoi membri (o “simbionti”), e che è costituita da una serie di patti politici e sociali conclusi successivamente dal basso, da una moltitudine di associazioni (o «consociazioni») autonome, naturali e istituzionali, pubbliche e private: famiglie e nuclei familiari vari, associazioni di mutuo soccorso e corporazioni, comunità civili e collegi secolari, città e province, ecc. Queste «consociazioni» si incastrano tra loro in un ordine che va dalla più semplice alla più complessa. Gli individui interagiscono tra loro ad ogni livello, non come singoli atomi, ma come membri di una comunità già esistente, che non rinuncia mai a tutti i suoi diritti a beneficio di una società più ampia. Althusius dà così alla nozione di rappresentanza un significato totalmente diverso da quello che è espresso dal pensiero contrattualista liberale: il contratto sociale non è per lui un atto unico risultante dal libero gioco delle volontà individuali, ma una «alleanza» (foedus) che si integra in un processo continuo di comunicazione «simbiotica» tra individui definiti soprattutto dalle loro appartenenze. La società globale, a cui Althusius dà il nome di «comunità simbiotica integrale», è quindi definita come un’organizzazione ascendente di comunità plurali, formate a loro volta sulla base di precedenti associazioni e di molteplici appartenenze, e sovrapposte l’una all’altra. Il corpo politico è il risultato di questo processo di inclusione della comunità, dove ogni livello trae la sua legittimità e capacità di azione dal rispetto dell’autonomia dei livelli inferiori. L’azione pubblica mira ad articolare a tutti i livelli la solidarietà reciproca e l’autonomia degli attori collettivi, il cui consenso deve essere reso possibile e organizzato in una dialettica aperta al generale e al particolare – l’idea fondamentale è che «ciò che coinvolge tutti deve anche essere approvato da tutti» («quod omnes tangit, ab omnibus approbetur»). In Althusius, la sovranità o «maestà» appartiene al popolo e non smette mai di appartenergli. È imprescrittibile perché risiede inalienabilmente nella comunità popolare, e «non c’è potere personale assoluto in una comunità». Le persone possono delegarlo, ma non rinunciarvi. Scrive Althusius che «il diritto di maestà non può essere ceduto, abbandonato o alienato dal suo proprietario […] Questo diritto è stato stabilito da tutti coloro che fanno parte del regno e da ciascuno di loro. Sono loro che lo danno alla luce; senza di loro, non può essere stabilito o mantenuto». Sempre Althusius precisa ulteriormente che «ho riportato i diritti di maestà alla politica. Ma li ho attribuiti al regno, cioè alla repubblica o al popolo», il quale aggiunge che non «si cura dei clamori di Bodin». Lungi dall’essere staccata dal popolo, la sovranità quindi emana direttamente da esso. Il principe svolge la sua funzione solo per derivazione del diritto permanente del popolo a governarsi da sé stesso. Non ha altra autorità che quella conferitagli dal popolo, non sotto forma di un trasferimento di potere a cui il popolo rinuncerebbe per un proprio vantaggio, ma per delega di un potere che il popolo non cessa in nessun momento di conservare intrinsecamente e sostanzialmente. In altri termini, il principe esercita il suo potere sotto il controllo del popolo e può usarlo solo al servizio del bene comune, che rimane il suo scopo principale. Non governa la società come se ne fosse posto al di sopra o fosse indipendente da essa. Non è il proprietario della sovranità, ma il suo custode; gode solo dei diritti di questa sovranità. Essa non è quindi assoluta, ma al contrario è ripartita o condivisa. Ispirato allo stesso tempo dal modello imperiale, dalle antiche «libertà» comunali germaniche e dal modo di operare delle associazioni e cooperative mutualistiche delle antiche città anseatiche, Althusius prevede che ad ogni livello della società si debbano trovare due serie di organi: alcuni rappresentano le comunità inferiori, che hanno il diritto di mantenere al loro livello tutto il potere che possono effettivamente esercitare; gli altri rappresentano il livello superiore, i cui poteri sono sempre limitati dal primo. Ogni livello nomina i propri leader, che sono anche i suoi rappresentanti al livello più alto, sulla base di una delega di potere che può essere revocata in qualsiasi momento. Poiché le deleghe sono condizionate, il potere del grado superiore si basa sempre sul consenso dei gradi inferiori. Lo Stato è superiore a ciascuno dei livelli che si trovano al di sotto di esso, ma non all’insieme che formano congiuntamente. Lo stesso principe, come abbiamo visto, esercita il suo potere sovrano per delega, sulla base di un patto reciproco di cui è considerato agente, e il popolo (la «comunità simbiotica») come suo mandante. Il potere del principe è infatti un potere supremo, poiché è quello con la giurisdizione più estesa, ma è comunque limitato dall’autonomia delle «consociazioni», il che gli impedisce di minare i poteri particolari di cui esse possono godere. Il principio di sovranità viene mantenuto, ma subordinato al consenso associativo. La sovranità in Althusius non è affatto sinonimo di onnicompetenza, come in Bodin, ma rappresenta solo il livello con poteri di autorità, decisione ed esecuzione più ampi. Il sovrano non è quello che può fare tutto a suo piacimento, senza dover rendere conto a nessuno. È quello che ha un potere più esteso degli altri, ma può usarlo solo nella misura in cui questo potere gli è riconosciuto o concesso. A tutti i livelli c’è uno «scambio di sovranità», vale a dire una differenziazione delle istanze, una condivisione delle competenze che vanno dal livello più basso verso il più alto. Mentre la sovranità bodiniana è sia una piramide che una circonferenza di cui tutta la superficie è ordinata verso il centro, la sovranità in Althusius è di tipo «labirintico»: implica la pluralità, l’autonomia, l’intreccio di livelli di potere e di autorità. La sovranità di tipo althusiano si è cristallizzata in passato in alcuni costruzioni imperiali o sovranazionali. Ne troviamo un’eco tra i teorici dell’austromarxismo come Otto Bauer e Karl Renner, entrambi sostenitori di uno «stato federale delle nazionalità», in cui la sovranità è distribuita a diversi livelli della società politica. Ma è soprattutto il federalismo che appare oggi come dottrina maggiormente in grado di mettere in pratica l’idea di una sovranità strettamente associata ai principi di autonomia e sussidiarietà. Quest’ultimo, che era già la chiave di volta del sistema di Althusius, richiede che le decisioni siano sempre prese al livello più basso possibile, da coloro che ne subiscono le conseguenze più direttamente. Ciò implica quindi che le unità politiche più piccole abbiano poteri autonomi sostanziali e siano allo stesso tempo rappresentate collettivamente a livelli di potestà più elevati. Non si tratta solamente di «decentralizzare». Nella «decentralizzazione», il potere locale non detiene altro che la parte di autorità che il potere centrale è disposto a concederle: non rappresenta altro che una delega di questo potere centrale, che resta il nucleo sostanziale della vita pubblica in una concezione della società rigorosamente piramidale. Con la sussidiarietà, il movimento è a rovescio: il livello locale delega ai livelli superiori solo le responsabilità e i compiti che non può svolgere da solo, chiede al livello superiore solo le competenze che non riesce ad avere, mentre risolve da solo tutte le problematiche che sono effettivamente di sua competenza, assumendo le conseguenze delle sue decisioni e scelte. La sussidiarietà rappresenta quindi una condivisione di competenze secondo il criterio di sufficienza o insufficienza: ogni livello di autorità conserva le competenze che può svolgere in autosufficienza. Ne consegue, ad esempio, che a ciascuna comunità, piuttosto che venirle imposta una fornitura standardizzata di beni e servizi, deve essere in grado di decidere liberamente quali beni e servizi ritiene idonei. La sussidiarietà è esattamente antagonista alla concezione bodiniana di sovranità che poggia, come abbiamo visto, non sul criterio della sufficienza, ma su quello della maggiore capacità. In questo schema, lo stato centrale può solo accentrare la piena autorità su sé stesso poiché, in linea di principio, si presume che sia sempre maggiormente capace. Nel sistema federale, al contrario, la delega si fa dal basso: sono i livelli inferiori che delegano ai vertici solo le decisioni per le quali non hanno i mezzi per prendere da soli. Ciò significa che «ogni organo del corpo sociale deve essere in grado di perseguire i propri fini il più liberamente possibile» (Robert Nisbet). Questa è l’idea di sussidiarietà: consentire alle persone di decidere il più possibile da sole su ciò che le riguarda creando un sistema politico e sociale in cui i problemi possono essere risolti al livello più basso possibile. Il termine essenziale qui è quello di autonomia.
*
Allo stesso modo, la concezione federalista di sovranità e sussidiarietà, che implica una politica di riconoscimento delle identità collettive, si oppone al principio di centralizzazione e al rifiuto giacobino di riconoscere la realtà delle differenze culturali, linguistiche, etniche e di altro tipo. La democrazia partecipativa si contrappone a quella puramente parlamentare e rappresentativa. I grandi teorici storici della rappresentanza sono Hobbes e Locke. In uno come nell’altro, infatti, il popolo delega contrattualmente la propria sovranità ai governanti. In Hobbes, questa delega è totale e consiste quindi nell’investire un monarca del potere assoluto (il «Leviatano»). Con Locke, la delega è al contrario condizionale: il popolo accetta di rinunciare alla propria sovranità solo in cambio di garanzie sui diritti fondamentali e sulle libertà individuali. La sovranità popolare è tuttavia eliminata o sospesa nel periodo che passa tra due elezioni. Rousseau, da parte sua, pone l’esigenza democratica come antagonista di qualsiasi regime rappresentativo. Il popolo, secondo lui, non stipula un contratto con il sovrano; la loro relazione è esclusivamente una questione di diritto. Il principe è solo l’esecutore del popolo che rimane l’unico detentore del potere legislativo. Non è nemmeno investito del potere che appartiene alla volontà generale; è piuttosto il popolo che governa attraverso di lui. Il ragionamento di Rousseau è molto semplice: se il popolo è rappresentato, è il suo rappresentante che detiene il potere, e in questo caso il popolo non è più sovrano. Il popolo sovrano è un «essere collettivo» che può essere rappresentato solo da sé stesso. Rinunciare alla sua sovranità sarebbe come rinunciare alla sua libertà, cioè come distruggere sé stesso. Non appena il popolo ha eletto i propri rappresentanti, «è uno schiavo, non è alcunché” (Il Contratto sociale, III, 15). La libertà, in quanto diritto inalienabile, implica la pienezza di esercizio senza la quale non può esserci una vera cittadinanza politica. La sovranità popolare non può che essere, a queste condizioni, indivisibile e inalienabile. Ogni rappresentanza corrisponde quindi ad un’abdicazione. Se ammettiamo che la democrazia sia il regime basato sulla sovranità del popolo, non possiamo che concordare qui con Rousseau, la cui opinione su questo punto – ma solo su questo – concorda indiscutibilmente con quella di Althusius.
La democrazia è la forma di governo che risponde al principio dell’identità tra governati e governanti, cioè tra la volontà popolare e la legge. Questa stessa identità si riferisce alla sostanziale uguaglianza dei cittadini, vale a dire al fatto che sono tutti ugualmente membri della stessa unità politica. Dire che il popolo è sovrano, non per essenza ma per vocazione, significa che è dal popolo che procedono il potere pubblico e le leggi. I governanti possono quindi esserne solo gli esecutori, i quali devono conformarsi ai fini determinati dalla volontà generale. Il ruolo dei rappresentanti deve essere ridotto il più possibile, il mandato rappresentativo perde ogni legittimità non appena si riferisce a fini o progetti che non corrispondono alla volontà generale. Tuttavia, questo è esattamente il contrario di ciò che sta accadendo oggi. Nelle democrazie liberali, il primato è assegnato alla rappresentanza, e più precisamente alla rappresentanza-incarnazione. Il rappresentante, lungi dall’essere solo «impegnato» ad esprimere la volontà dei suoi elettori, incarna lui stesso questa volontà semplicemente in virtù del fatto di essere eletto. Ciò significa che trova nella sua elezione la giustificazione che gli consente di agire, non più secondo la volontà di chi lo ha eletto, ma secondo la sua – in altre parole, si considera autorizzato per voto a fare quello che lui stesso ritenga bene fare.
Questo sistema è all’origine delle critiche che non hanno mai smesso, in passato, di essere dirette contro il parlamentarismo, critiche che si stanno riprendendo oggi, in Europa, attraverso tutta una serie di dibattiti sul «deficit democratico» e la «crisi della rappresentanza». Nel sistema rappresentativo, avendo l’elettore delegato con le elezioni la sua volontà politica a chi lo rappresenta, il centro di gravità del potere risiede inevitabilmente nei rappresentanti e nei partiti che li raggruppano, e non più nel popolo. La classe politica forma così un’oligarchia di professionisti che difendono i propri interessi, in un clima generale di confusione e irresponsabilità. A questo si aggiunge oggi, in un momento in cui chi ha potere decisionale lo acquisisce molto più comunemente dalla nomina o dalla cooptazione che dall’elezione, un’altra oligarchia di «esperti», alti funzionari e tecnici. Lo Stato di diritto, di cui i teorici liberali celebrano regolarmente le virtù, nonostante tutte le ambiguità legate a questa espressione, non sembra in grado di correggere la situazione. Basato su una serie di regole e procedure legali formali, è indifferente a fini politici specifici. I valori sono esclusi dalle sue preoccupazioni, lasciando così il campo aperto allo scontro di interessi. Le leggi vi hanno autorità solo perché sono legali, cioè conformi alla Costituzione e alle procedure previste per la loro adozione. La loro legittimità si riduce allora alla loro legalità. Questa concezione positivista-legalista della legittimità ci invita a rispettare per sé stesse le istituzioni, come se queste costituissero un fine in quanto tali, senza che la volontà popolare possa modificarle e controllarne il funzionamento. Tuttavia, in una democrazia, la legittimità del potere non dipende solo dalla conformità alla legge o alla Costituzione, ma dipende soprattutto dalla conformità della pratica di governo ai fini ad essa assegnati dalla volontà generale e popolare. La giustizia e la validità delle leggi non possono dunque risiedere interamente nell’attività dello Stato o nella produzione legislativa del partito al potere. Allo stesso modo, la legittimità della legge non può essere garantita dalla mera esistenza del controllo giudiziario: perché la legge sia legittima, deve anche rispondere a ciò che i cittadini si aspettano da essa e incorporare finalità orientate al servizio del bene comune. Infine, si può parlare di legittimità della Costituzione solo quando si riconosce l’autorità del potere costituente come sempre capace di modificarne la forma o il contenuto. Ciò equivale a dire che il potere costituente non può essere totalmente delegato o alienato, che continua ad esistere e rimane superiore alla Costituzione e alle regole costituzionali, anche quando da essa deriva. È evidente che non possiamo mai sfuggire completamente alla rappresentanza, poiché l’idea di una maggioranza governativa si scontra con difficoltà insormontabili nelle società moderne. La rappresentanza, che non è mai solo un tappabuchi, non esaurisce il principio democratico. Può in larga misura essere corretta mediante l’attuazione della democrazia partecipativa, nota anche come democrazia organica o democrazia incarnata. Un tale riorientamento sembra ancora oggi essere sempre più necessario a causa dell’evoluzione generale della società. La crisi delle strutture istituzionali e la scomparsa delle «grandi storie» fondanti, la crescente disaffezione dell’elettorato per i partiti politici tradizionali, il rinnovamento della vita associativa, l’emergere di nuovi movimenti sociali o politici (ambientalisti, regionalisti, identitari) la cui comune caratteristica non è più il difendere gli interessi negoziabili bensì i valori esistenziali, lasciano intravedere la possibilità di ricreare una cittadinanza attiva a partire dal basso. La crisi dello Stato-nazione, dovuta in particolare alla globalizzazione della vita economica e allo spiegamento di fenomeni di influenza planetaria, da parte sua dà luogo a due modalità di superamento: dall’alto, con vari tentativi di ricreare a livello sovranazionale, una coerenza e una efficienza nel processo decisionale che consentirebbe, almeno in parte, di guidare il processo di globalizzazione ricreando un mondo multipolare; dal basso, con la rinnovata importanza delle piccole unità politiche e delle autonomie locali. Queste due tendenze, che non solo non si oppongono ma si completano a vicenda, implicano entrambe la necessità di affrontare il deficit democratico a cui assistiamo attualmente. Non è al livello delle grandi istituzioni collettive, tutte oggi più o meno entrate in crisi e che non possono più svolgere il loro ruolo tradizionale di integrazione e intermediazione sociale, che è possibile ricreare una cittadinanza così attiva. Né il controllo del potere può essere la sola prerogativa dei partiti politici la cui attività è troppo spesso risolta in clientelismo. Oggi la democrazia partecipativa può essere solo una democrazia di base. Questa democrazia di base non mira a generalizzare la discussione a tutti i livelli, ma piuttosto a determinare, con l’aiuto del maggior numero possibile di persone, nuove procedure decisionali secondo le proprie esigenze e quelle derivanti dalle aspirazioni dei cittadini. Né può ridursi a una semplice opposizione della «società civile» alla sfera pubblica, cosa che equivarrebbe ad allargare ulteriormente l’influenza del settore privato e ad abbandonare l’iniziativa politica a forme di potere obsolete. Si tratta, al contrario, di permettere agli individui di vedere sé stessi come cittadini, e non come membri di un’entità privata, favorendo il più possibile l’emergere e il moltiplicarsi di nuovi spazi pubblici di iniziativa e responsabilità.
La procedura referendaria (sia che derivi dalla decisione dei governanti o dall’iniziativa popolare, sia che il referendum sia facoltativo o obbligatorio) è solo una forma di democrazia diretta tra le altre – di cui forse abbiamo sopravvalutato la portata. Sottolineiamo ancora una volta che il principio politico della democrazia non è quello per cui la maggioranza decide, ma quello per cui il popolo è sovrano. Il voto stesso è solo un mezzo tecnico per consultare e rivelare opinioni del popolo. Ciò significa che la democrazia è un principio politico che non può essere confuso con i mezzi che utilizza, né può essere ridotto a un’idea puramente aritmetica o quantitativa. La qualità del cittadino non si esaurisce nel voto. Consiste piuttosto nell’individuare tutti i metodi utilizzabili per manifestare o negare il consenso, per esprimere un rifiuto o un consenso. È quindi necessario esplorare sistematicamente tutte le possibili forme di partecipazione attiva alla vita pubblica, che sono anche forme di responsabilità e fiducia in sé stessi, poiché la vita pubblica condiziona l’esistenza quotidiana di tutti. Ma la democrazia partecipativa non è solo di portata politica, ha anche un impatto sociale. Promuovendo rapporti di reciprocità, consentendo la ricreazione di un vincolo sociale, può aiutare a ricostituire solidarietà organiche oggi indebolite, a ricreare un tessuto sociale disaggregato dall’ascesa dell’individualismo e dalla fuga in avanti nel sistema della concorrenza e dell’interesse. In quanto produttrice di socialità elementare, la democrazia partecipativa va poi di pari passo con la rinascita di comunità viventi, la ricreazione della solidarietà di vicinato, di quartiere, e dei luoghi di lavoro, ecc. Questa concezione partecipativa della democrazia è in diretta opposizione alla legittimazione liberale dell’apatia politica, che incoraggia indirettamente l’astensione e conduce al regno di dirigenti, esperti e tecnici. La democrazia, in fin dei conti, poggia meno sulla forma di governo vera e propria e più sulla partecipazione del popolo alla vita pubblica, in modo che il massimo della democrazia si confonda con il massimo della partecipazione. Partecipare significa prendere parte, vivere sé stessi come parte di un insieme o di un tutto, e assumere il ruolo attivo che risulta da questa appartenenza. René Capitant ha detto che «la partecipazione è l’atto individuale del cittadino che agisce come membro della comunità popolare». Ciò mostra quanto siano strettamente collegate le nozioni di appartenenza, cittadinanza e democrazia. La partecipazione attiene alla cittadinanza, che deriva dall’appartenenza. L’appartenenza giustifica la cittadinanza, che consente la partecipazione.
Questi mi sembrano i fondamenti essenziali del federalismo: una società in cui libertà e responsabilità, strettamente legate tra loro, sono distribuite a tutti i livelli secondo il principio di sussidiarietà; una concezione della sovranità, che non ne fa un potere assoluto e onnicomprensivo, ma che solo attiene all’organo che ha autorità come ultima risorsa sugli ambiti più ampi; e, infine, una concezione della democrazia che poggia non sulla nozione di numero o su quella di deliberazione parlamentare, ma soprattutto su quella della partecipazione più ampia possibile di tutti i cittadini agli affari pubblici.
Alain de Benoist
(Traduzione a cura di Manuel Zanarini)