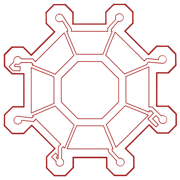Sono passati 100 anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini (1922-1975). «Io? Sono una vitalità disperata» diceva di sé stesso. E’ morto così come ha vissuto. Come un semi-Dio. Consegnato al massacro dell’opinione pubblica, con la complicità di dèi gelosi, Orfeo immolato, il cui canto non sta per estinguersi, ma che stringe il cuore e fa serrare i pugni agli uomini.
In ogni discorso pubblico che si rispetti, c’è sempre un preambolo. Questa è una dichiarazione d’amore all’autore, per quanto goffa possa essere. Per quali ragioni custodiamo la memoria di Pasolini, chiunque tra noi, giovani, meno giovani, atei, vecchi cristiani, comunisti retrogradi, eterosessuali intransigenti e omosessuali rigorosi? Perché resta, al di là della religione di ciascuno, una delle espressioni più strazianti della vitalità e della disperazione, dell’obbedienza e della disobbedienza, della giovinezza del mondo e dell’antichità dell’uomo, del padre e del figlio, dell’eroe e del martire.
In una delle sue poesie miracolose, fragile come una nuvola d’argento, risponde ingenuamente a un’attrice evidentemente stupida che gli chiede, senza ridere, che cos’abbia lui, Pasolini, al suo attivo, con i suoi occhiali scuri, la sua stranezza, il suo sorriso angelico uscito da un quadro di Caravaggio e il suo volto addolorato modellato nella carne di un pugile e di una rondine. Sì, allora che cosa ha al suo attivo Pasolini, colui che fa film così difficili?
«Io? Sono una vitalità disperata»
Queste due parole riassumono la sua vita, come un epitaffio. Pasolini si pone ai due estremi della bellezza, su una scala che va da Arthur Rimbaud a Charles Péguy e da Jean Genet a Simone Weil, e che, nella più perfetta reversibilità di colpa e salvezza, unisce attorno alla sua persona i due ministeri, la poesia e la profezia, che danno alla sua voce il suo timbro unico e il suo doppio splendore di pietà e di bellezza.
La grazia e lo scandalo
Ecce homo. Ecco l’uomo, ecco l’eretico che ha sempre rifiutato di integrarsi con i meccanismi del potere, ecco il «luterano» che ha esposto le sue «tesi» sullo schermo televisivo della società dei consumi. Colui che discese nella sua epoca, finché essa si allontanò da lui e lui a sua volta si allontanò da lei, abbandonandola alla parola falsa, secondo l’espressione di Armand Robin, e ai suoi simulacri. Uno dei portavoce della sua generazione, certamente, ma anche la sua cattiva coscienza sporca. Sia eroe che Cassandra, bambino saggio e figlio cattivo, Don Giovanni delle lande desolate e statua del Commendatore, in breve, colui che trasgredisce e colui che giudica. «Lavoro tutto il giorno come un monaco / e la notte mi aggiro come un gatto / in cerca di amore…». Cercando piuttosto il sesso, perché l’amore, per così dire, lo ha trovato per tutta l’eternità nella dolcezza di una madre, per la quale provava una passione violenta, ideale, santa, teneramente incestuosa. Edipo sarà anche una delle figure centrali della sua vita, magistralmente messo in scena in uno dei suoi film più belli.
Innanzitutto, il padre, militare e fascista, sarà restituito alla conformità del suo stato. L’antifascismo del figlio conterrà una dimensione psicologica, tanto familiare quanto storica. Ma quando il figlio si riapproprierà dell’eredità del padre, il fascismo cesserà di essere l’ostacolo supremo. Pasolini finirà anche per vivere uno «scandaloso rimpianto», quello dell’Italia fascista e prefascista. La sua condanna della modernità coincide con la scoperta, l’addomesticamento, si potrebbe dire, della figura paterna. In tal modo, si strappa via dai mondi nascosti dell’inconscio.
La poesia fornisce tutte le chiavi mancanti di Pasolini. È l’alfa e l’omega della sua vita. Egli è alternativamente, come nella permutazione dei ruoli nel teatro greco, il beato e il maledetto degli dèi, il loro agente e il loro rivale. Il Pasolini poeta ci lascia intravedere quello che Georges Haldas chiamava lo stato della poesia. In altre parole, la poesia lo abita sotto le vesti della grazia e dello scandalo. È un poeta, ma è anche poetico. È un uomo, ma in più è riuscito a rimanere in parte divino. Si muove in una sfera diversa rispetto ai poeti di professione, prigionieri dei trattati letterari e dei limiti della forma-poesia. Ha la delicatezza, la purezza, la ferocia di una giovane vergine e di un Centauro, tanto che amando religiosamente il mondo, compie i riti della bellezza senza mai sbagliare, come i primitivi e i bambini.
L’occhio interiore
Prima esperienza del mondo, la poesia ha sempre preceduto i suoi romanzi, i suoi film, i suoi impegni. Egli è prima di tutto un poeta, prima della Storia; solo dopo viene il suo stato civile. Italiano, regista, scrittore, omosessuale. Questo sigillo di poesia è la stella sulla fronte, come diceva Raymond Roussel. «Sono preso», scrive ne La lunga strada di sabbia, «da una tale gioia nel vedere le cose che divento quasi cieco». E noi con lui. Pasolini sta sulla soglia della creazione del mondo, ne è il testimone privilegiato, se non l’ospite e il primo officiante. Siamo continuamente accecati dalla luce cruda che getta sulle cose. È come se strappasse brutalmente il sipario di un universo per lui increato. La visione del mondo diventa così evidente che i paesaggi e i rilievi riacquistano la loro originaria verginità, come dopo qualche ignoto sconvolgimento geologico, inondati di una luce immacolata, ripuliti dal deflusso di una pioggia lustrale. Il poeta è colui che battezza il mondo e gli somministra l’ultimo sacramento. Due linguaggi sono alla sua portata, quello degli inizi e quello della fine: il mitico e l’apocalittico, che la poesia di Pasolini tiene con entrambe le braccia.
Ma in questa fase, il veggente e il redivivo non hanno ancora finito di svelare i segreti di quest’opera poetica, perché essa ha ancora un’altra dimensione, quella che guarda dentro il poeta, nella sua intimità. È l’occhio interiore. È il luogo in cui scoppiano tutte le sue contraddizioni, come un immenso lapsus, il lapsus del comunismo, l’ammissione dell’esitazione di fronte all’impegno. In tutte le poesie, Pasolini abbandona il suo «cuore elegiaco» alle confidenze, al lettore, moltiplicando autoritratti e autocritiche. Qui, nel mosaico sciolto dei versi liberati, traccia i contorni di un’autobiografia suggestiva, intensamente lirica, toccante, incompiuta come se fosse un disegno. Spoglia la sua biografia di tutti i suoi inutili orpelli. Del suo progressismo, del suo narcisismo, del conforto delle posizioni acquisite. Diventa un traditore del suo secolo e un estraneo alla sua famiglia. Come minimo, uno strano fratello, insondabile, il quale sacrifica a un Dio sibillino versi misteriosamente dolci, soavi nella lingua pasoliniana (l’epiteto principe dell’opera). L’artista che fa politica svanisce: fa politica e fa un’altra cosa.
Io sono una forza del passato
Pasolini è una terra incognita sull’atlante delle rappresentazioni politiche. È solo ed è tutto. È ovunque e non è da nessuna parte. Non appartiene più realmente alla Sinistra, se non attraverso un cordone ombelicale sempre più sottile. Non è riconducibile affatto alla Destra. Se l’antifascismo lo colse presto (leggendo Rimbaud a sedici anni), rinunciò rapidamente alle strutture retoriche degli antifascisti, stando fuori dalle correnti, dalle confraternite e dai clan. Piuttosto che lo schema Destra-Sinistra, interseca un’altra linea, l’unico confine decisivo, quello che separa gli Antichi dai Moderni. È qui che si deve cercare la sua geografia politica, su una vecchia mappa di mondi precedenti.
«Io sono una forza del passato/ Alla tradizione solo va il mio amore». Inconsolabilmente disperato, come il nervaliano diseredato in Le Chimere, Pasolini arriva a vedersi come un uomo di troppo, un uomo d’altri tempi, un uomo passato, che piange per la fine del mondo (non c’era un altro che non fosse il suo). Il suo Dio è morto, il suo popolo è morto. Si instaura allora tra lui e i mondi schiacciati dalla legge ferrea del progresso una potente nostalgia.
Marxista tanto quanto antimoderno, moderno ma con un modernismo reazionario, è ridotto, per mancanza di meglio, a fare affidamento sulla forza d’inerzia declinante di una tradizione sempre più minacciata, a malapena capace di arginare il laminatoio della società consumistica. A tal fine, il regista ha in qualche modo mescolato nell’humus delle grandi tradizioni popolari. Boccaccio e il Decamerone, Chaucer e i Racconti di Canterbury, le Mille e una notte, il Vangelo di Matteo. Non appena vede arrivare il popolo, si affretta a seguirlo. Gli appartiene emotivamente. Anche nei brandelli culturali, il popolo rimane resurrezionale ai suoi occhi. Lo strappa alla sua estrazione piccolo-borghese. È la sua patria, l’unico inno che gli scalda il petto.
Mille lire in più in tasca, il prezzo del tradimento
A Pasolini non piaceva la storia. In qualunque modo la si guardi, risulta sempre altrettanto piatta, lineare, uniformemente borghese. Il suo unico sollievo consiste nella monotona progressione della curva delle vendite, sotto la quale si vedrà l’«ultimo uomo» di Nietzsche crollare sotto forma di trofeo definitivo. Pasolini contrappone a Kojève e Hegel un astoricismo poetico fondamentale, legato alla materialità di una lotta per la sopravvivenza delle classi e delle identità. Il suo comunismo era vernacolare. In questo, c’è qualcosa di diverso dal marxismo di Marx. Pasolini vedeva nella modernità un processo di integrazione nella borghesia, e un tale processo gli sembrava senza scampo. In fondo, tiene ancora con sé Marx solo perché è stato precedentemente emendato da Gramsci. Antonio Gramsci gli ha permesso di non dover scegliere tra Il Capitale e la poesia, tra materialismo storico e mito. Cercando di far luce sul fallimento della rivoluzione nella penisola italiana, Gramsci fu portato a italianizzare il proletariato e proletarizzare l’Italia. Ma la sua analisi si basava su com’era ancora il suo Paese negli anni ’20. Nel frattempo, gli universi nazional-popolari sono crollati. Non c’è più il popolo italiano, non più il sottoproletariato, i contadini, coloro che svolgono i piccoli mestieri, per fare una rivoluzione-restaurazione. In pochi anni il mondo plebeo scomparve, passando dalla società preindustriale all’età del Ferro e del Cemento, per mille lire in più in tasca.
Se Pasolini rimase vicino al PCI, lo fece partendo da una base cristiana e materna. Non poteva rinnegare completamente il cattolicesimo senza in qualche modo rievocare sua madre e la tradizione contadina da cui lei proveniva. Comunista perché conservatore, si scontrò con il conformismo della sinistra e l’inamovibile fascismo degli antifascisti. Questo è il principale rimprovero alla sua famiglia d’origine, rimasta inguaribilmente fissata al 1945, in una rivolta infantile, che è come una sorta di ostacolo epistemologico, bloccando il suo orizzonte impedendo di analizzare e criticare la società post-fascista. Ora, il grande leitmotiv pasoliniano, sia nelle poesie che nelle opere polemiche, e che acquista rapidamente una dimensione litanica, è che il fascismo non ha intaccato di un centimetro l’anima del popolo, mentre il neo-fascismo capitalista l’ha irrimediabilmente profanata e distrutta. L’ideologia fascista non ha suscitato un’adesione profonda. Esercitava una violenza che veniva da fuori, segnata principalmente dall’uso del manganello e dell’olio di ricino (tranne alla fine). Come in Amarcord di Fellini. Il capitalismo è virale, gassoso, anestetico, subliminale, omicida. Non possiamo opporre resistenza ad esso, tanto è acconsentito e volontario. Servitù volontaria, lavoro salariato suicida.
François Bousquet
Traduzione a cura di Manuel Zanarini
(François Bousquet, Revue Éléments, “Pasolini : « Je suis une force du passé » (1/2)”, 11 aprile 2022)