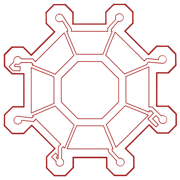Circola da qualche tempo un meme che contrappone l’idea degli anni Ottanta dominante nell’immaginario attuale a ciò che “crescere negli anni Ottanta” ha realmente significato per i più. Da una parte luci al neon, arredi avvenieristici, atmosfere retrowave. Dall’altra toni smorti, mobilio della nonna, aria da tombolata di Natale con gli zii. Si potrebbe dire che La chimera di Alice Rohrwacher è un film che rende giustizia a questo aspetto dimenticato e autentico del decennio, agli antipodi di Miami Vice e della Milano da bere.
Ma nel film in realtà c’è molto di più, ed è ciò che il personaggio di Arthur, il protagonista, riassume in una frase, rivolta ad una statua etrusca trafugata da un sepolcro: “La tua bellezza non è fatta per gli occhi degli uomini”. Il ricordo di una bellezza perduta, indicibile a parole, è il fil rouge – anche nel senso letterale, come scoprirà lo spettatore – della narrazione. La bellezza dei reperti di cui una banda di tombaroli fa razzia nelle campagne tra la Tuscia e la bassa Toscana, ma anche quella della donna che Arthur ha amato e perduto, l’eterea Beniamina. Arthur è lui stesso un tombarolo, appena uscito di galera dopo un colpo finito male. Di lui e del suo passato nulla si rivela, se non che è straniero – inglese o irlandese -, che è capitato lì – un paese indeterminato dell’alto Lazio – per interessi archeologici, forse come studente, che è stato legato a Beniamina prima che lei morisse, in circostanze anch’esse destinate a rimanere inconoscibili.
Arthur ha un dono: è un rabdomante. Non nel senso più classico, legato cioè all’individuazione delle vene d’acqua. Ciò che lui è in grado di “avvertire” è la presenza di sepolcri, le vestigia dell’antica Etruria che in quegli anni, complici una minore sensibilità al tema e una più diffusa impreparazione delle forze dell’ordine, era ancora possibile saccheggiare più o meno a man salva e rivendere sul mercato nero dei collezionisti. Il dono di Arthur è “la sua chimera”, come spiega l’amica Fabiana. Arthur è un uomo diviso a metà, stretto tra l’esigenza di fare cassa con quello che trova nella terra e un profondo rispetto per un mondo a cui si sente legato da fili invisibili, e di cui – sebbene straniero – lui solo sembra riconoscere la persistenza. Nella scena iniziale del film osserva in treno una ragazza e le dice che il suo profilo ricorda quello delle fanciulle ritratte negli affreschi delle tombe: lei e le amiche ne ridono, senza capire. Le stesse ragazze, insieme al controllore e a un petulante venditore di calzini, compariranno ad Arthur in una visione carica di sensi di colpa: lo straniero vede i viaggiatori avvicinarsi nel corridoio del treno e chiedergli con gentilezza dove sia “il mio corredo funebre”. C’è chi cerca una kylix con un cervo dipinto, chi una fibula. In quel momento Arthur comprende davvero la natura sacrilega di ciò a cui lui e gli amici si erano dedicati fino ad allora. Credendo di rubare sotto terra, assecondando un’ancestrale pulsione contadina alla ricerca di mitici tesori, stavano in realtà rubando “alla” terra: ogni coccio sottratto, ogni statua decapitata per poterla trasportare in pezzi, è un legame reciso tra il mondo dei morti e quello dei viventi.
Invano aveva provato ad avvertirli l’altro personaggio cardine del film, dal nome emblematico di Italia, la sola ad opporsi al saccheggio di una tomba individuata su una spiaggia, ai piedi di un mostruoso insediamento industriale. Anche lei è una straniera – si direbbe brasiliana – e anche di lei si sa poco: vive nella villa bellissima e cadente di Flora, l’anziana madre di Beniamina, l’unica amica sincera di Arthur. Presentata come studentessa di canto della padrona di casa, le fa in realtà da governante. Arthur la raggiungerà dopo la presa di coscienza, deciso a dare una svolta alla sua vita da ladro e da irregolare. Ma la fiamma fredda dell’attrazione per il passato – per i tesori etruschi e per Beniamina – si rivelerà alla fine inestinguibile in lui. Davvero felice, lo si capisce dopo aver visto il film, è la scelta di rappresentarlo nella locandina sotto le spoglie dell’Appeso dei tarocchi: un arcano dalla natura ambigua, irrisolto ma al tempo stesso capace di osservare ciò che gli altri non possono vedere.
C’è un protagonista silente nel film ed è la terra che fa da sfondo alla vicenda. La Saturnia tellus, “ombelico” della penisola in senso metastorico, spirituale prima che geografico. Il Lazio interno con la sua anacronistica frugalità, tuttora palpabile per chi si allontani dalle rotte turistiche. L’Italia – si potrebbe dire – di Vermicino, per citare un evento eclatante nella memoria collettiva di quegli anni, che oltre a fondare l’odierna “tv del dolore” mostrò il volto di un Paese ancora arcaico e dignitoso. Un Paese che sempre in quegli anni veniva spogliato delle sue vestigia come oggi – forse – non accade più nemmeno nel terzo mondo, perlomeno non sulla stessa scala con cui il Getty Museum di Los Angeles trafficava reperti di provenienza illecita, guadagnandosi la famigerata nomea di “museo dei tombaroli”. La scena clou del film comincia con il trasporto di una meravigliosa statua su una nave container, dove viene occultata in una cassa contenente palloni da calcio con i colori della bandiera italiana, stile Italia ’90: seguirà l’asta tra i curatori dei musei. A chi scrive quella scena ha ricordato un aneddoto riguardante la guerra d’indipendenza greca di inizio Ottocento. Si dice che un comandante avesse fermato alcuni miliziani mentre stavano per accordarsi sulla vendita di una statua antica, in modo da poter comprare altra polvere da sparo da usare contro i turchi: “Non capite? È per quella statua che stiamo combattendo” gli avrebbe detto l’ufficiale.
Vero o falso che sia, l’aneddoto coglie il senso di quella bellezza ineffabile che il protagonista di La chimera scorge nel profilo meraviglioso di una dea etrusca scolpita più di duemila anni fa, così come in quello della ragazza che gli sedeva a fianco in treno: un invito a ricordare ciò che si è, a rispettare la bellezza “che non è fatta per gli occhi degli uomini”, ma che negli occhi degli uomini sopravvive in un’eco di eternità.