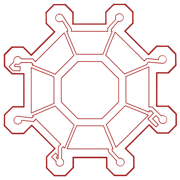Oggi tutti parlano di mondialismo, un fenomeno importante del nostro tempo a cui diamo ancora più importanza perché generalmente lo consideriamo irreversibile. Questo fenomeno sembra infatti imporsi come un movimento di trasformazione del mondo sul quale nessuno ha più controllo. Un maremoto, in un certo senso, irreversibile sull’orizzonte di almeno diverse generazioni. Gli anglosassoni preferiscono parlare di «globalizzazione». Non è senza interesse sapere che questa nozione di globalizzazione è stata messa in circolazione dall’altra parte dell’Atlantico da strateghi del marketing di massa che, a partire dagli anni ’80 del 900, hanno iniziato a parlare di «prodotto globale» o di «comunicazione globale» , alludendo così al principio secondo cui la stessa merce deve, grazie appunto alla pubblicità, raggiungere il più rapidamente possibile il maggior numero possibile di potenziali clienti, non adattandosi a culture diverse, ma veicolando una cultura globale. Ma cosa dovremmo intendere per «globalizzazione»? Nonostante il gran numero di lavori recenti su questo argomento (1), il concetto rimane confuso. Per alcuni, la globalizzazione è soprattutto un fenomeno di superamento dello Stato nazionale; per altri, tale termine definisce un nuovo tipo di opposizione tra capitale e lavoro indotta dalla finanziarizzazione del capitale; o, addirittura, esprime una nuova scissione tra lavoro qualificato e non qualificato. Alcuni la vedono come l’irruzione nel commercio mondiale di nuovi attori del Sud del globo, contemporaneamente alla strategia di globalizzazione delle imprese multinazionali; altri pongono l’accento sull’espansione del commercio dovuta all’integrazione dei servizi nel commercio mondiale; ma anche al grande cambiamento determinato dalla rivoluzione informatica. Di cosa si tratta esattamente?
Penso che dobbiamo primariamente distinguere, da un lato, la globalizzazione culturale e, dall’altro, la globalizzazione economica e finanziaria. Sono due fenomeni che si sovrappongono in larga misura, ma che non vanno confusi tra loro. Una delle caratteristiche più evidenti della globalizzazione economica è l’esplosione degli scambi commerciali e dei flussi finanziari. Il commercio internazionale sta oggi crescendo più velocemente della produzione nazionale (PIL). Nel 1990, la quota del commercio internazionale rappresentava il 15% del PIL mondiale. In soli cinque anni, dal 1985 al 1990, le esportazioni mondiali sono aumentate del 13,9%. Il commercio di merci è raddoppiato tra il 1960 e il 1989, mentre i flussi di capitali sono quadruplicati. Allo stesso tempo, la natura dei flussi finanziari è cambiata: il continuo sviluppo degli investimenti diretti all’estero è stato accompagnato da un’esplosione di movimenti di capitali a breve termine. Questi investimenti diretti stanno aumentando anche più velocemente della ricchezza mondiale: il loro tasso di crescita annuale è passato dal 15% tra il 1970 e il 1985 al 28% tra il 1985 e il 1990, periodo durante il quale sono quadruplicati in volume, da 43 miliardi di dollari nel 1985 a 167 miliardi nel 1990. Stiamo quindi assistendo all’avvento di un’economia globale, con una quota crescente del PIL che dipende direttamente dal commercio estero e dai flussi di capitali internazionali. L’altra grande caratteristica è ovviamente quella rappresentata dal ruolo crescente dell’informatica e dell’elettronica. Riducendo il costo delle transazioni a lunga distanza e rendendo possibile conoscere in «tempo reale», ovunque nel mondo, le informazioni che contribuiscono alla formazione dei prezzi, cosa che prima richiedeva settimane affinché fossero conosciuti in pochi centri finanziari, le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione consentono ora una mobilità dei flussi finanziari senza precedenti. Il sole non tramonta più sulle borse interconnesse. Il capitale si muove alla velocità della luce, da un capo all’altro del globo, alla ricerca del miglior ritorno degli investimenti. Questa globalizzazione finanziaria è particolarmente importante: il mercato dei capitali è infatti l’unico in cui l’arbitrato istantaneo ha un senso. Grazie a questa mobilità istantanea resa possibile dall’interconnessione IT, le transazioni nel mercato forex sono cresciute enormemente. Adesso raggiungono i 1.200 miliardi di dollari al giorno! Queste somme provengono contemporaneamente dalle attività bancarie, dalle tesorerie delle imprese multinazionali, dalla massa del capitale flottante e dalle somme detenute dalle società finanziarie appositamente costituite per svolgere questo esercizio. Le fondamenta del sistema stanno nelle differenze di cambio che, da un giorno all’altro, e anche da un’ora all’altra, possono garantire notevoli guadagni di plusvalore, molto maggiori di quelli derivanti dalle attività industriali o commerciali classiche. In funzione dell’anticipazione dei tassi di scambio, l’informatizzazione consente l’immediato spostamento virtuale di grandi masse di capitali, che sfuggono quasi completamente alle banche centrali. Abbiamo giustamente parlato di «economia da casinò» per designare questo fenomeno. Il risultato è una sempre maggiore instabilità monetaria e una tendenza dei tassi di interesse ad allinearsi al rialzo con i migliori rendimenti assicurati dall’apprezzamento globale del capitale. Alcuni autori fanno cominciare la globalizzazione all’inizio degli anni ’70, segnata in particolare dal doppio shock petrolifero e dalla crisi del sistema dei cambi internazionali. È in questo periodo che abbiamo assistito al rallentamento della produttività e del tasso di crescita nei paesi industrializzati; a una graduale saturazione della domanda di beni di consumo durevoli classici, di cui il rinnovamento è diventato la componente principale; all’aumento del vincolo finanziario esterno; mentre l’abbandono dei tassi di cambio fissi e l’esplosione del deficit dei pagamenti americano portano alla proliferazione di prodotti finanziari puramente speculativi. Il processo è proseguito negli anni ’80, con l’esplosione del debito pubblico, che ha favorito lo sviluppo di un vasto mercato dei capitali, e soprattutto con l’ondata di deregolamentazione che, a partire dalla presidenza Reagan negli Stati Uniti, ha preso piede rapidamente in tutti i Paesi sviluppati. Gli Stati iniziano quindi a battere in ritirata di fronte al crescente potere dell’integrazione finanziaria adottando le «tre D» di decompartimentazione, disintermediazione e deregolamentazione, che, liberalizzando completamente il mercato dei capitali, consentono di realizzare arbitrati a livello globale e di aprire il mercato dei crediti dello Stato e delle grandi imprese a favore di operatori esteri. Allo stesso tempo, a cavallo degli anni Novanta, la scomparsa quasi improvvisa del sistema sovietico e l’improvvisa transizione dei paesi ex comunisti al sistema del capitalismo selvaggio hanno portato all’irruzione di 2,5 miliardi di persone in più sul mercato mondiale, diffondendo allo stesso tempo l’illusione di un pianeta unitario in cui ci sarebbe stato un solo blocco. Questa serie di eventi, tuttavia, deve essere collocata in una sequenza temporale molto più ampia. Lungi dal rappresentare una deviazione aberrante dal sistema capitalista, o da poter essere interpretata come una novità radicale, o addirittura come il risultato di una cospirazione, la globalizzazione è infatti in linea con una dinamica secolare propria della natura stessa del capitalismo. «La tendenza a creare un mercato mondiale è inclusa nel concetto stesso di capitale», osservava Karl Marx nel secolo scorso (2). Philippe Engelhard non ha torto a scrivere che «la globalizzazione è senza dubbio solo l’ultimo spettacolo pirotecnico nell’esplosione della modernità occidentale» (3). La globalizzazione è infatti il culmine di tutta una serie di metamorfosi che hanno scandito, nel corso della sua storia, un’economia di mercato caratterizzata fin dall’inizio dall’apertura degli scambi in un clima di individualismo-universalismo basato sulla metafisica della soggettività e sulla valorizzazione del solo successo materiale. Inizia con lo sviluppo del commercio a lungo raggio, durante il periodo delle città-stato italiane, nel XIV secolo. È continuato con le «grandi scoperte» e la rivoluzione industriale, e poi con il colonialismo. Tra il 1860 e il 1873, l’Inghilterra era già riuscita a creare un nucleo del nuovo sistema commerciale mondiale. Nel luglio 1885, Jules Ferry dichiarò alla Camera dei deputati che «la fondazione di una colonia è la creazione di un mercato». Favorendo la disintegrazione delle culture e delle società tradizionali dell’Africa e dell’Asia, il colonialismo favorisce quindi la penetrazione dei prodotti occidentali e apre nuove postazioni commerciali, una pratica che non verrà abbandonata finché non avrà perso la sua redditività, cioè quando le colonie iniziano a costare più di quanto fruttino (4). L’istituzione del mercato è essa stessa storicamente inseparabile da un vasto movimento di internazionalizzazione del commercio. Nella teoria economica classica, come affermato nel XVIII secolo, la libera circolazione di beni e servizi dovrebbe già portare a un’equalizzazione dei sistemi produttivi e degli standard di vita. Il capitalismo appare così fin dall’inizio come nomade. Come nota Jacques Adda, la globalizzazione «restituisce al capitalismo solo la sua originaria vocazione transnazionale, piuttosto che internazionale, che è quella di abbattere i confini statali, le tradizioni nazionali, per meglio sottomettere tutto all’unica legge del valore» (5). Tuttavia, se è indiscutibile che la globalizzazione rappresenti per molti aspetti solo un’accelerazione improvvisa di un processo secolare, è altrettanto certo che presenta un certo numero di nuove caratteristiche, che si possono passare in rassegna rapidamente.
Oltre alla rivoluzione informatica, di cui ho già parlato, oltre al fatto che, nel commercio internazionale, sono ormai i manufatti a predominare sulle materie prime, occorre registrare lo straordinario guadagno di autonomia della sfera finanziaria in relazione alla produzione economica propriamente detta. La grande deregolamentazione del mercato azionario degli anni ’80 ha infatti consacrato l’avvento di un capitalismo che non è principalmente industriale, ma speculatore. L’offerta di moneta in circolazione nel mondo oggi è stimata in più di quindici volte il valore della produzione! Questa «bolla» finanziaria raccoglie fondi sia dall’economia privata che dall’economia pubblica e sociale, sia che si tratti della gestione del debito pubblico dello Stato che dei fondi pensione di anzianità. In modo del tutto naturale, impone una logica speculativa, persino criminale: droga e corruzione stanno diventando elementi strutturali del nuovo ordine economico. Un altro fatto nuovo: la mercificazione generalizzata. Le transazioni odierne riguardano settori che prima ne erano in larga misura escluse. La cultura, il mondo dell’arte, le competizioni sportive, i servizi, le risorse naturali, i prodotti di proprietà intellettuale vengono trasferiti al libero scambio. Il gioco del mercato opera nel senso di trasformare tutte le cose in beni economici. Ciò che entra nel sistema come un essere vivente ne esce come una merce, come un prodotto morto.
Ma soprattutto gli attori non sono più gli stessi. Ieri questi attori erano soprattutto gli Stati. Oggi, le multinazionali dominano gli investimenti e il commercio, mentre i mercati finanziari dettano le loro regole e le banche gestiscono un settore finanziario sempre più disconnesso dall’economia reale. Stiamo così passando da un mondo organizzato intorno agli Stati-nazione a una «economia-mondo» strutturata attorno ad attori globali. Questa è ovviamente una trasformazione essenziale. Alcuni decenni fa, gli Stati nazionali borghesi costituivano il naturale quadro politico e sociale per la gestione dei sistemi produttivi nazionali. Fondamentalmente, la concorrenza intercapitalista aveva luogo tra gli Stati. La caratteristica dominante del sistema capitalista era allora la sua territorializzazione, cioè il suo radicamento entro i limiti di una nazione industriale. Anche il mercato, seppur in espansione, era prevalentemente nazionale. Lo stesso valeva anche per le imprese con società controllate all’estero dove la centralità strategica rimaneva situata nel Paese di riferimento della società guida di tale gruppo. Economia e politica coincidevano quindi in termini generali, da qui l’importanza della politica economica portata avanti dallo Stato. Infine, il Terzo Mondo non era ancora entrato nel sistema industriale, determinando un contrasto estremamente marcato tra i grandi centri industrializzati e le periferie.
Oggi, l’integrazione globale del capitale ha frantumato i sistemi produttivi nazionali e avviato la loro ricostruzione come tanti segmenti di un sistema produttivo globalizzato. Le diverse componenti della produzione sono ormai disperse in una cornice spaziale molto lontana dalle origini geografiche dell’azienda, e talvolta anche indipendente dal suo controllo finanziario. I prodotti incorporano componenti tecnologiche di origine così varia che non si può più riconoscere quella complessiva, né il contributo specifico di ciascuna nazione, né la nazionalità della forza lavoro impegnata nella produzione. Robert Reich sottolinea, ad esempio, che quando un americano acquista un’auto dalla General Motors che paga $ 20.000, di questa somma che paga, meno di $ 800 vanno ai produttori americani. La globalizzazione produce quindi una riorganizzazione dello spazio planetario, caratterizzata prima di tutto da una deterritorializzazione generalizzata del capitale. Si passa così da uno «spazio di luoghi» a uno «spazio di flusso», cioè dal territorio alla rete (6). La rete non corrisponde più a nessun territorio, ma si inscrive nel mercato globale, e si emancipa da ogni vincolo politico-statale. Per la prima volta nella storia, lo spazio dell’economia e lo spazio della politica sono separati. Questa è una delle caratteristiche più essenziali della globalizzazione.
Ho appena citato le multinazionali. La comparsa di imprese industriali capaci di pensare fin dall’inizio del loro sviluppo su scala mondiale e di attuare strategie globali integrate è un’altra caratteristica della globalizzazione. Le multinazionali sono imprese che realizzano più della metà del proprio fatturato all’estero. Nel 1970 erano 7.000, oggi sono 40.000, controllano 206.000 filiali, ma danno lavoro solo al 3% della popolazione mondiale (cioè 73 milioni di persone). Per avere un’idea della loro importanza e del loro potere, basti sapere che nel 1991 hanno realizzato da sole un fatturato superiore alle esportazioni mondiali di beni e servizi (cioè 4.800 miliardi di dollari), che controllano direttamente o indirettamente un buon terzo del reddito mondiale, e che le 200 più importanti tra loro monopolizzano un quarto dell’attività economica del pianeta. Va inoltre notato che quasi il 33% del commercio mondiale è ormai effettuato tra filiali della stessa impresa, e non tra imprese diverse. Queste aziende di rete hanno risorse che sfidano l’immaginazione. Il fatturato annuo di General Motors (177,2 miliardi di dollari nel 2001) supera il PIL dell’Indonesia; quello di Ford (177,2 miliardi di dollari) supera il PIL della Turchia; quello di Toyota, il PIL del Portogallo; quello di Unilever, il PIL del Pakistan; quello di Nestlé, il PIL dell’Egitto. La prima azienda americana, la catena di distribuzione Wal-Mart (219,8 miliardi di dollari di fatturato, 1,3 milioni di dipendenti), il cui valore di borsa è cresciuto di oltre il 400% negli ultimi cinque anni, ha registrato un utile di 6,67 miliardi di dollari nel 2001. Queste imprese, la cui origine nazionale non è altro che un riferimento puramente formale, hanno da tempo imparato a sostituire obiettivi di minima redditività con obiettivi di massimizzazione dei guadagni finanziari, quali che siano le conseguenze sociali. Meno interessati alla produzione che al controllo dei mercati e dei brevetti, sono soprattutto i gruppi finanziari che investono la maggior parte dei loro profitti in valute estere o derivati, invece di ridistribuirli ai propri azionisti o investirli in attività creatrici di posti di lavoro. Essendo più ricchi di molti Stati, non è nemmeno difficile per loro comprare politici e corrompere funzionari o intere amministrazioni.
Anche per far fronte alla concorrenza le multinazionali hanno sviluppato una nuova strategia. Poiché i profitti della produzione non trovavano più sbocchi sufficienti negli investimenti convenzionali, ne hanno dovuto trovare altri per l’eccedenza dei capitali flottanti, per evitare la loro massiccia e brutale svalutazione, come era accaduto negli anni Trenta. La lotta per acquisire quote di mercato le ha quindi spinte a incorporare nel salariato mondiale una forza lavoro scarsamente qualificata e sottopagata, al fine di beneficiare di un vantaggio di costo assoluto (7). Mentre i Paesi occidentali un tempo si accontentavano di sfruttare il mercato interno di quelli del Sud, trasferendo le attività artigianali nelle loro proprie industrie, le multinazionali stanno ora lavorando per riesportare nei mercati occidentali prodotti assemblati o fabbricati in quei Paesi a prezzi bassi. La globalizzazione avviene quindi attraverso il rientro di una parte dell’attività economica dai Paesi del Sud, attraverso una riorganizzazione globale del ciclo produttivo e la mobilitazione di una forza lavoro locale trasformata in lavoratori salariati. Questo fenomeno cosiddetto di delocalizzazione, divenuto generale a partire dagli anni ’80 del 900, non è altro che l’estensione-riorganizzazione del rapporto salariale su scala globale, vale a dire un passo avanti verso la creazione di un mercato globale del lavoro. Va da sé che, in questa prospettiva, la libertà di movimento del capitale è essenziale, per deviare i profitti verso i centri decisionali responsabili della loro allocazione, movimento che ha il duplice effetto di ridurre la capacità di accumulazione locale e limitare l’aumento del potere d’acquisto (8).
Allo stesso tempo, assistiamo all’irruzione nel commercio mondiale di nuovi operatori provenienti dall’Asia e, in misura minore, dall’America Latina e dall’ex impero sovietico. Anche questo è un fatto nuovo. In passato, le differenze di costo del lavoro tra Nord e Sud valevano generalmente la metà rispetto alle differenze di produttività e qualità del prodotto. L’emergere di Nuovi Paesi Industrializzati (NPI) e la comparsa di multinazionali in alcuni paesi del Sud hanno cambiato radicalmente la situazione. Nel 1995, il reddito pro capite di Singapore aveva già superato quello della Francia. Questo fenomeno è ovviamente destinato ad aumentare. A tal proposito, si segnala che il successo dei NPI non consacra in alcun modo la verità delle tesi liberali. Il «miracolo asiatico» è infatti radicato prima di tutto in uno specifico tessuto culturale (9), dove anche il nazionalismo fa la sua parte, sia in Giappone che in Cina, in Corea o in Singapore. Si spiega anche con il volontarismo delle politiche industriali di questi Paesi che, lungi dall’allinearsi a una teoria dei vantaggi comparati che li avrebbe obbligati a specializzarsi, senza preoccuparsi della domanda effettiva, nelle produzioni con costi relativi più bassi, al contrario, si sono rivolti in via prioritaria a produzioni soggette a forte domanda su scala globale. La globalizzazione, ovviamente, cambia la competizione tra le nazioni, perché una volta che le imprese e i capitali possono muoversi liberamente nel Mondo, la competitività delle imprese nazionali non si fonda più automaticamente con quella delle nazioni. Lo spazio transnazionale in cui operano le grandi imprese non ha più motivo di coincidere con l’organizzazione ottimale degli spazi nazionali. La posizione di un Paese nel mondo non è più definita dal livello di capacità competitiva delle sue produzioni sul mercato mondiale, essendo i suoi imprenditori tenuti a posizionarsi in questo mercato secondo il miglior rapporto rendimento/rischio o vantaggio/costo. In definitiva, poiché le nazioni non sono altro che punti nello spazio produttivo delle grandi imprese, la nozione stessa di vantaggio comparativo diventa obsoleta. Gli Stati non hanno quindi altra risorsa che ripiegare su politiche di pura competitività, a discapito delle esigenze di coesione sociale. È proprio ciò che è accaduto in Europa a partire dagli anni Ottanta, prima sotto l’influenza delle teorie liberali attuate da Ronald Reagan negli Stati Uniti e da Margaret Thatcher in Gran Bretagna, poi sotto l’effetto dei «criteri di convergenza» del Trattato di Maastricht. Questo adeguamento alle esigenze della globalizzazione ha assunto le forme che conosciamo: deregolamentazione e liberalizzazione generalizzate; priorità data all’esportazione rispetto al consumo interno; privatizzazione delle imprese pubbliche; apertura agli investimenti internazionali; determinazione dei prezzi e dei salari da parte del mercato globale; graduale eliminazione di aiuti e sussidi; senza dimenticare la riduzione delle spese che dovrebbero rallentare la competitività, come l’istruzione, la protezione sociale o la tutela dell’ambiente. Uno dopo l’altro, gli Stati europei hanno così adottato una politica strettamente monetarista, nota come disinflazione competitiva, che consisteva nel combattere l’inflazione attraverso alti tassi di interesse, e il cui risultato più evidente è stato quello di rallentare la crescita e aumentare la disoccupazione, mentre il capitale finanziario, tassato meno del reddito da lavoro, contribuiva sempre meno al benessere generale della collettività.
Allo stesso tempo, la crisi del debito ha costretto i paesi del Terzo Mondo a intraprendere una svolta analoga: i programmi di aggiustamento strutturale richiesti dal FMI e dalla Banca Mondiale hanno portato la maggior parte di loro ad applicare le stesse ricette dei paesi industrializzati, con risultati ancora più catastrofici. Le organizzazioni internazionali sono così diventate strumenti al servizio della globalizzazione. Il ruolo del FMI e della Banca Mondiale è quello di imporre la deregolamentazione, di gestire la fluttuazione delle valute e di sottoporre le economie del Terzo Mondo all’assoluto imperativo dell’indebitamento. Il G8 sta cercando di coordinare le politiche di gestione delle crisi dei principali Paesi sviluppati, senza affrontare i problemi di fondo. Ma un ruolo molto speciale spetta alle organizzazioni responsabili della supervisione del commercio mondiale. In passato, i negoziati commerciali interstatali si concentravano su un piccolo numero di pratiche nazionali, come quote di importazione, tariffe, controllo dei movimenti di capitale, ecc. Oggi, le sfide della diplomazia commerciale si estendono ben oltre le questioni di confine concentrandosi sulle istituzioni interne dei Paesi: la struttura del loro sistema bancario, i termini dei loro diritti di proprietà privata, la loro legislazione sociale, le loro regole in materia di concorrenza, concentrazione o proprietà industriale, ecc. Il principio alla base di questi negoziati è che il commercio internazionale deve coinvolgere nazioni con più o meno le stesse istituzioni, orientarsi verso un diritto di proprietà e della sua regolamentazione uniformi, il più delle volte allineati con il diritto statunitense, in modo da ridurre l’incertezza e i rischi per gli investimenti diretti dall’estero. Il potere contrattuale delle imprese multinazionali risulta così rafforzato, dotate di una nuova capacità di pressione che consente loro di chiedere adeguamenti in termini normativi, salariali o fiscali, al fine di aumentare la propria redditività e competitività. In definitiva, «attraverso un numero crescente di negoziazioni locali e internazionali, le società si trovano di fronte alla richiesta di trasformare le proprie regole e istituzioni interne per conformarsi a un modello imposto dall’esterno» (10). Le clausole del GATT o dell’Organizzazione mondiale del commercio (WTO) vanno quindi ben oltre gli obiettivi tradizionali degli accordi di libero scambio. Mirano soprattutto a promuovere la mobilità dei capitali. Gli accordi che ne derivano sono infatti non tanto accordi di libero scambio quanto accordi di libera circolazione dei capitali, volti a stabilire nuovi diritti di proprietà internazionali per gli investimenti esteri e creare nuove restrizioni alle normative nazionali e governative. Come scrive Ian Robinson, «gli accordi di libera circolazione dei capitali possono essere intesi come strumenti che, in nome della riduzione delle barriere al commercio, alterano o rinegoziano le leggi, le politiche e le pratiche esistenti, sulla via per un’economia di mercato globale» (11).
Infine, un’altra novità, non meno importante poiché è questa che permette di comprendere la natura della globalizzazione culturale: il capitalismo non vende più solo, come ieri, merci e beni, ma vende anche segni, suoni, immagini, software, plug-in e collegamenti. Non arreda solo le case, colonizza l’immaginario e domina la comunicazione. Mentre negli anni Sessanta la società dei consumi si nutriva ancora di beni materiali identificabili (automobili, elettrodomestici, ecc.), il sistema che Benjamin R. Barber ha recentemente proposto di chiamare «McWorld» – come Macintosh o McDonald’s – costituisce un universo essenzialmente virtuale, risultante dall’intensificarsi di flussi transnazionali di ogni tipo che convergono a produrre una crescente omogeneizzazione degli stili di vita. Barber afferma che «i supporti del sistema McWorld non sono più le automobili, ma il parco a tema Eurodisney, il canale musicale MTV, i film di Hollywood, i programmi per computer. Insomma, concetti e immagini considerati tanto quanto oggetti» (12). Questa mercificazione diffusa instaura il consumo pubblicitario-spettacolare come forma unica di integrazione sociale, mentre esacerba sentimenti di esclusione e impulsi aggressivi in coloro che non possono permetterselo. Contribuisce, attraverso un diluvio di immagini e suoni universali, alla già avviata standardizzazione degli stili di vita, alla riduzione delle differenze e delle peculiarità, all’allineamento di atteggiamenti e comportamenti, allo sradicamento delle identità collettive e delle culture tradizionali. La globalizzazione non può quindi essere confusa con la semplice internazionalizzazione, che era il sistema creato e organizzato dagli Stati per definire le forme delle loro relazioni internazionali (13). Piuttosto, si definisce come il passaggio da un’economia internazionale concepita come un aggregato di economie nazionali e locali differenti tra loro nei principi operativi e regolatori, ad una vera e propria economia di mercato planetaria, governata da un sistema di regole uniformi, nel modo definito da Karl Polanyi (14). Consiste in «una crescente interdipendenza che unisce tra loro tutte le componenti del nostro spazio mondiale per condurle verso una sempre più esigente uniformità e integrazione» (15). Coloro che la guidano sono nuovi attori extra-statali ed extranazionali, che aspirano solo a massimizzare i propri dividendi e profitti pianificando e ottimizzando l’organizzazione planetaria delle loro attività, ed eliminando tutto ciò che può ostacolare la loro libertà di azione. E questi nuovi attori, che rafforzano ogni giorno di più la loro autonomia, sono essi stessi sempre più interdipendenti, fino a costituire un’unica immensa organizzazione commerciale.
*
Una volta compresa l’esatta natura della globalizzazione economica e finanziaria, è facile coglierne le conseguenze. La prima è ovviamente quella di un tragico aggravarsi delle disuguaglianze economiche. Già Hegel evidenziava come le società ricche non lo sono abbastanza da assorbire la crescente miseria che generano. Oggi la povertà non è più il risultato della scarsità, ma della cattiva distribuzione, della ricchezza prodotta, insieme a un blocco psicologico e culturale che impedisce di considerare il ritorno a società che non si definiscono principalmente intorno ai concetti di lavoro e di produzione. Tra il 1975 e il 1985 il prodotto lordo mondiale è aumentato del 40%; dal 1950, il commercio mondiale è aumentato di undici volte e la crescita economica di cinque volte. Tuttavia, nello stesso periodo, abbiamo assistito non a un aumento regolare del tenore di vita medio, ma a un aumento senza precedenti della povertà, della disoccupazione, della disgregazione dei legami sociali e della distruzione dell’ambiente. Il PIL reale pro capite nei paesi del Sud rappresenta oggi solo il 17% di quello del Nord. Il mondo industriale, che comprende solo un quarto dell’umanità, detiene da solo l’85% della ricchezza globale. I paesi membri del G8 rappresentano l’11% della popolazione mondiale, ma possiedono i due terzi del PIL del pianeta. La sola città di New York consuma più elettricità di tutta l’Africa subsahariana. Tra il 1975 e il 1995, la ricchezza americana è aumentata complessivamente del 60%, ma questo aumento è stato accaparrato dall’1% della popolazione. Un ultimo dato rivelatore: la ricchezza in dollari dei 358 miliardari oggi presenti nel Mondo da sola supera i redditi anni cumulati dai 2,3 miliardi più poveri, ovvero l’equivalente di quasi la metà dell’umanità. Vediamo che più c’è ricchezza, più ci sono poveri, il che rovina la teoria liberale secondo la quale tutta la società dovrebbe finire per beneficiare dei profitti generati dai più ricchi. In realtà, poiché restituisce alle forze di mercato un quasi monopolio, la globalizzazione contribuisce allo sviluppo delle disuguaglianze e dell’esclusione sociale, minacciando così la coesione delle società. Allo stesso tempo, il colonialismo continua in modo informale. Gli aiuti al Terzo Mondo hanno perfezionato la tecnica del prestito e dell’usura come mezzo di controllo. L’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) “avverte” ora i Paesi del Sud di concedere un trattamento «nazionale» agli investimenti esteri, eliminando ogni ostacolo rappresentato dalla legislazione sul lavoro, sull’ambiente o sulla salute. Tuttavia, ovunque siano stati posti in essere sistemi liberali di adeguamento strutturale, i risultati sono stati il peggioramento delle condizioni di vita della maggior parte delle persone e l’aumento dell’instabilità sociale – la quale, attraverso un giusto ritorno alle azioni, provoca peraltro la fuga di capitale, che permette di evidenziare la natura fondamentalmente parassitaria di questo sistema. Per quanto riguarda i Paesi che si rifiutano di soddisfare questi requisiti, essi sono semplicemente emarginati, lasciati indietro e infine respinti dai circuiti internazionali.
Ma ovviamente non è solo nei paesi del Sud che queste conseguenze si fanno sentire. Al Nord, la globalizzazione si traduce in un’esacerbata competizione transnazionale che, attraverso le esportazioni e gli investimenti diretti, sta provocando un vero e proprio abbattimento dei salari e dell’occupazione. Qualsiasi bene o servizio prodotto localmente, ma che potrebbe essere prodotto altrove a un costo inferiore, diventa vulnerabile alla pressione esercitata dal capitale a favore di salari e oneri sociali più bassi, mentre, per converso, l’aumento del costo del lavoro legato alla scarsità di capitale umano e i costi dell’invecchiamento demografico incoraggiano gli imprenditori a spostare le proprie attività in Paesi in cui la manodopera è più economica e più «flessibile». Le produzioni competitive nei Paesi in via di sviluppo, essendo soprattutto quelle che incorporano molta manodopera non qualificata, sono incoraggiate e sfruttate al Sud, e progressivamente escluse dall’occupazione nei Paesi del Nord, cosa che contribuisce all’aumento della disoccupazione strutturale. In assenza di sbocchi per la crescita, le imprese dal canto loro possono raggiungere la dimensione critica per sopravvivere nei mercati globali solo sottraendo quote di mercato ai concorrenti e migliorando costantemente la propria competitività, cosa che si traduce in un continuo movimento di ristrutturazione e ridimensionamento industriale (downsizing) con effetti sociali devastanti. Tuttavia, le delocalizzazioni sono solo all’inizio. Nel 1990, i manufatti esportati dai Paesi di nuova industrializzazione (PNI) del sud-est asiatico verso i paesi OCSE rappresentavano ancora solo l’1,61% del PIL di quest’ultimo. In Francia, il commercio con i PNI genera al massimo un punto dell’attuale tasso di disoccupazione. Ma il fenomeno è destinato a svilupparsi. Tra il 1970 e il 1990 la quota dei Paesi emergenti nel commercio OCSE è passata dallo 0,70% al 6,44 %. A questo ritmo, potrebbe raggiungere il 55% in vent’anni. La rivoluzione industriale aveva reso possibile l’integrazione di personale non qualificato nella società globale. Con la globalizzazione, al contrario, si assiste alla sistematica esclusione di chi non ha competenze utili. Si tratta, rispetto alla precedente fase del capitalismo, di una rottura fondamentale che mette in discussione tutti i compromessi sociali adottati dal welfare state keynesiano. Globalizzazione dei salari e globalizzazione finanziaria concorrono infatti a invertire il corso della politica economica e sociale che aveva presieduto ai decenni di crescita del dopoguerra. Durante i Trent’anni gloriosi, che corrispondevano all’apice del sistema fordista, il capitalismo dovette fare i conti con le rivendicazioni sociali formulate nelle società industriali, nonché con la volontà degli Stati di porre le basi di un ordine economico internazionale. Il Welfare State aveva rappresentato il risultato di questo storico compromesso tra capitale e lavoro, cioè di questo adeguamento delle strategie del capitale ad un certo numero di domande sociali. La globalizzazione ha rotto questo contratto sociale. A partire dagli anni ’70, la logica economica del capitalismo ha iniziato a disconnettersi dalle rivendicazioni sociali, il che ha portato a una messa in discussione generalizzata della gerarchia dei salari e dei meccanismi di solidarietà collettiva. Questa sconnessione dell’economia e del sociale è andata di pari passo con la dislocazione della coppia stato sociale/classe media, attorno alla quale si è costruita la crescita dei decenni precedenti. Con la globalizzazione stiamo assistendo all’emergere di un modello di società a clessidra – dove la stragrande maggioranza degli abitanti tende a cadere verso il basso sotto l’effetto della precarietà, mentre il denaro è polarizzato nelle alte sfere – fenomeno che segna l’inizio della destrutturazione delle classi medie, cioè di quelle classi «che i capitalismi del primo Novecento non solo avevano addirittura generato, ma sulle quali avevano anche basato la loro crescita» (16). Durante i Trent’anni gloriosi, queste classi medie continuarono a consolidarsi, portando all’integrazione al loro interno di fasce sempre più ampie della popolazione, e quindi ad una relativa riduzione delle disuguaglianze. È questo modello di classe media, che si espanderà gradualmente fino a includere la classe operaia in un modo che si credeva irreversibile, che viene messo in discussione oggi. Il risultato è una profonda trasformazione dei rapporti di classe e di interesse all’interno dei Paesi capitalistici. In effetti, alla destrutturazione delle classi medie corrisponde una parallela destrutturazione delle classi lavoratrici, che stanno assistendo alla messa in discussione delle loro conquiste sociali, ma anche dei loro tradizionali strumenti di difesa, che i sindacati ovviamente non hanno nei confronti delle imprese multinazionali abituate a giocare sull’aumento delle differenze salariali all’interno del mercato globale e dei poteri di pressione che hanno nei confronti delle autorità pubbliche con cui sono abituati a negoziare. Questo sviluppo equivale a una formidabile regressione, poiché equivale a ripristinare situazioni di sovrasfruttamento paragonabili a quelle che il movimento operaio dovette combattere agli albori del capitalismo industriale. Karl Marx, nonostante la sua filosofia difettosa della storia, aveva almeno capito che la logica della cattura delle passioni che è all’opera nel capitalismo si traduce nella reificazione delle relazioni umane. Si può apprezzare l’ironia della storia nel momento in cui il sistema comunista sovietico è crollato, le sue tesi trovano una certa rilevanza di fronte a una logica del profitto che si impone senza il minimo ritegno, mentre la disoccupazione e la povertà ancora una volta diventano fattori strutturali della società, poiché nel XXI secolo, precarietà ed esclusione si diffondono ogni giorno di più, e il reddito da capitale continua ad aumentare a discapito del reddito da lavoro, e che le garanzie ottenute dai lavoratori dopo decenni di lotte vengono messe in discussione una dopo l’altra.
Ultima conseguenza della globalizzazione: la crescente impotenza degli Stati nazionali. A causa dell’accelerazione della mobilità internazionale dei capitali, della globalizzazione dei mercati e dell’integrazione delle economie, i governi vedono ridursi il proprio margine di azione macroeconomica. In materia monetaria, il loro margine di manovra è già quasi nullo, poiché i tassi di interesse e i tassi di cambio sono ora soggetti all’autorità di banche centrali indipendenti che prendono le loro decisioni in base all’andamento del mercato: un Paese (o un gruppo di Paesi) che decidesse unilateralmente di tagliare i suoi tassi di interesse causerebbe immediatamente una fuga di capitali verso Paesi che offrono maggiori possibilità di guadagno. Allo stesso tempo, la capacità di mobilitazione monetaria delle banche centrali è scesa al di sotto del volume delle transazioni: nel luglio 1993, in un solo giorno di attacco speculativo contro il franco, la Banque de France ha perso tutte le sue riserve valutarie! Anche in materia di bilancio, gli Stati vedono ridursi il proprio margine di libertà a causa di un elevato debito pubblico che impedisce loro ogni stimolo non concertato. In termini di politica industriale, infine, i governi non hanno altra soluzione per resistere alla concorrenza che cercare di attirare le imprese estere attraverso sussidi e trattamenti fiscali privilegiati, che li mettono in balia delle richieste delle imprese multinazionali. Tuttavia, esse non si fermano a trascendere i confini. Come abbiamo visto, pesano anche sui quadri legislativi che dovrebbero regolarne l’operatività. Tasse o salari troppo alti, condizioni di lavoro socialmente troppo pesanti, li spaventano. Di conseguenza, «qualsiasi forma di regolamentazione può essere soggetta a pressioni al ribasso da parte del mercato semplicemente perché le multinazionali vi vedono un costo» (17). Il potere fiscale degli Stati non è più sovrano, ma contrattuale, perché necessariamente negoziato con capitali sempre più erratici, e quindi sempre più capaci di imporre le proprie condizioni. «Nessun governo, nemmeno al Nord», spiega Edward Goldsmith, «ha più controllo sulle multinazionali. Se una legge interferisce con la loro espansione, queste minacciano di andarsene e possono farlo all’istante. Sono libere di girare il pianeta per scegliere la manodopera più economica, l’ambiente meno protetto dalla legge, il sistema fiscale più economico, i sussidi più generosi. Non hanno bisogno di identificarsi con una nazione o di lasciare che un attaccamento sentimentale ostacoli i loro progetti. Sono totalmente fuori controllo» (18). In definitiva, aggiunge Jacques Adda, «la globalizzazione finanziaria può essere analizzata come un processo di elusione delle regole stabilite dagli Stati più sviluppati nel quadro di un sistema multilaterale di regolamentazione dell’economia mondiale» (19).
L’economia globalizzata pone quindi vincoli così severi agli Stati e questi ultimi stanno gradualmente vedendo tutti i loro mezzi d’azione tradizionali relegati al deposito merci. Di fronte alle crescenti difficoltà nel controllo della ricchezza, gli Stati si trovano privati di una leva politica essenziale: lo sviluppo coerente sul loro territorio. E poiché ogni sforzo di bilancio in campo sociale sembra essere stato sottratto alla loro capacità di competitività economica, non possono più svolgere il loro ruolo di gestione dei compromessi sociali. I politici allora diventano impotenti e lo Stato cambia natura: da mediatore sociale quale era, gli viene affidato un semplice ruolo di gestione territoriale dei flussi che lo oltrepassano. Ridotto al ruolo di spettatore, non è altro che «una sorta di impiegato che registra decisioni prese altrove» (20).
Un tale cambiamento è rivoluzionario, in quanto mina quello che era stato uno dei fondamenti della politica moderna: la sovranità degli Stati. Come scrive Bertrand Badie, «la globalizzazione rompe le sovranità, squarcia i territori, abusa delle comunità costituite, sfida i contratti sociali e rende obsolete certe concezioni di sicurezza internazionale […] Quindi la sovranità non è più questo valore fondamentale indiscusso quale era in precedenza a causa del fatto che l’idea di ingerenza cambia lentamente ma inesorabilmente di connotazione» (21).
Ma sono anche e soprattutto i principi democratici a essere colpiti. La legittimità che i dirigenti traggono dalla loro elezione da parte del popolo (dai cittadini) viene messa in discussione non appena essi non hanno più i mezzi per interporsi tra le esigenze del capitale e i bisogni del corpo sociale. D’altra parte, la libera circolazione dei capitali restringe anche il campo del controllo democratico sulle politiche economiche e sociali, poiché queste politiche sono soggette a vincoli esterni ai quali i governi non possono più sottrarsi, e per i quali stiamo assistendo al trasferimento del potere decisionale a beneficio di attori economici globali che non sono responsabili nei confronti di chicchessia. La cittadinanza diventa così inoperante e priva di significato – al punto che ci si può chiedere cosa possa volere significare «prendere il potere» in un mondo come questo.
*
La globalizzazione cambia anche la nostra percezione dello spazio e del tempo. Sotto le maglie dei satelliti in orbita geostazionaria, sotto l’influenza di imperi economici che moltiplicano alleanze e fusioni, sotto l’effetto delle «autostrade dell’informazione» che trasportano nei luoghi più remoti del pianeta la stessa sub-cultura globale, il pianeta si restringe. Dominato da monopoli sempre meno numerosi ma sempre più potenti, lo spazio in cui circolano merci, investimenti e capitali si va via via uniformando. D’altra parte, mentre fino ad ora, tutte le società avevano abitato il tempo sia nella successione dei momenti sia nella continuità della durata, questa distinzione viene cancellata. La rivoluzione tecnologica del «tempo reale» (o «tempo zero») accelera la circolazione dei flussi materiali e immateriali, senza possibilità di parametri di riferimento o di prospettiva. Questa compressione temporale fa dell’immediatezza l’unico orizzonte di senso rimasto. Come dice René Char: «Eliminare le distanze, uccide». L’avvicinamento prodotto dalle nuove tecnologie della comunicazione determina lo schiacciamento di esseri e cose, la confusione di forme e momenti.
È dunque una ridefinizione della realtà stessa a cui stiamo assistendo. Internet è un buon esempio. Mentre i media tradizionali si limitano a mostrare ciò che accade altrove, Internet consente ai suoi utenti di trasportarsi virtualmente in questo altrove. L’abitante del sistema McWorld vive così ovunque e da nessuna parte allo stesso tempo; Internet inaugurando un nuovo modo di vivere, che potremmo chiamare nomadismo elettronico, ma che è anche colonialismo elettronico se osserviamo bene. Nelson Thall, successore di Marshall McLuhan all’Università di Toronto, afferma infatti che «in definitiva, il potere di Internet… è che consente al mondo intero di pensare e scrivere come i nordamericani».
Non è un’esagerazione, quindi, dire che la globalizzazione produce in qualche modo l’abolizione dello spazio e del tempo. L’abolizione del tempo deriva dal fatto che, grazie a tecniche di informazione e comunicazione istantanee, tutto accade e si propaga ormai in «tempo zero»: gli stessi eventi (che si tratti di un attacco spettacolare o della finale di un Mondiale FIFA) sono visti e «vissuti» allo stesso tempo dagli spettatori di tutto il mondo; i flussi finanziari vengono trasmessi istantaneamente da un capo all’altro della terra; e così via. Quanto all’abolizione dello spazio, è dovuta al fatto che i confini non fermano più nulla, per cui nessun territorio ha una centralità particolare.
Al tempo della Guerra Fredda, c’era un confine tra il mondo comunista e quello che allora veniva audacemente chiamato il «mondo libero». Oggi non c’è più una linea di demarcazione. Le informazioni, i programmi, i flussi finanziari, i beni, le persone stesse, circolano sempre più liberamente da un Paese all’altro o sono distribuiti contemporaneamente in tutti i Paesi. All’interno di ogni Paese, la distinzione tra interno ed esterno non corrisponde più a nulla. In passato, ad esempio, la polizia era responsabile del mantenimento dell’ordine interno, mentre l’esercito era responsabile degli interventi esteri. È significativo che oggi la polizia ricorra sempre più frequentemente a mezzi militari, mentre l’esercito sia impegnato principalmente in «operazioni di polizia internazionale». La globalizzazione segnala così l’avvento di un mondo senza esterno. Il neologismo «globalitarismo» è stato inventato per descrivere questo mondo che non ha più nulla al di sopra di esso, questa azienda globale che per natura non è limitata da alcunché. L’avvento della globalizzazione corrisponde quindi alla fine della modernità. La caduta del muro di Berlino, per utilizzare un comodo punto di riferimento, non segnò solo la fine del dopoguerra o la fine del XX secolo, ma ha rappresentato anche l’ingresso nella post-modernità. Nel mondo postmoderno tutte le forme politiche ereditate dalla modernità stanno diventando obsolete. La vita politica non è più solo competizione tra partiti. Il modello «leninista», in cui i partiti cercano di arrivare al potere per attuare il loro programma, è ampiamente superato, poiché lo spazio di manovra dei governi si riduce ogni giorno di più. Gli Stati nazionali perdono sia la loro centralità che la loro legittimità. La loro centralità perché ormai troppo grandi per soddisfare le aspettative quotidiane delle persone, ma allo stesso tempo troppo piccoli per far fronte allo spiegamento globale di problemi e vincoli. La loro legittimità perché, essendo entrati in crisi uno dopo l’altro i crogiuoli istituzionali di integrazione su cui un tempo facevano affidamento (la scuola, l’esercito, i sindacati, i partiti, ecc.), essi non sono più produttori di socialità. Il vincolo sociale viene quindi ricostituito lontano dalle autorità amministrative e dalle istituzioni sovrastanti. La globalizzazione porta a un divorzio tra significato e segno, che si traduce in una desimbolizzazione generalizzata della vita politica. La crisi della rappresentanza, l’aumento dell’astensione alle consultazioni elettorali, la fioritura del populismo e dei nuovi movimenti sociali, sono ancora altri sintomi caratteristici di questo sviluppo.
Si assiste contemporaneamente alla fine degli Stati-nazione a beneficio delle comunità e degli spazi continentali; alla fine delle organizzazioni di massa a vantaggio delle reti; alla fine del modello esplosione/rivoluzione a favore dell’implosione/dispersione; alla fine delle logiche territoriali a favore di quelle transnazionali; al termine dell’individualismo solitario in favore dell’intersoggettività dei gruppi.
Il mondo globalizzato è soprattutto un mondo di reti. Le reti si caratterizzano per il loro carattere «liquido» o fluttuante – tutto è questione di flussi (di moneta, di simboli, di immagini, di programmi), di velocità, di connessioni – garanzia della loro opacità relativa, e non hanno né centro né periferia, il che significa che ogni punto della rete è esso stesso sia centrale che periferico. Le reti creano un nuovo tipo di relazioni sociali «frazionate». Instaurando un legame immediato tra individui che vivono a grande distanza gli uni dagli altri, secondo le loro affinità, le loro opinioni o i loro centri di interesse, creano nuove identità sovranazionali. Le reti oggi sono di tutti i tipi: reti industriali e finanziarie, reti di informazione e comunicazione, reti criminali, reti terroristiche, ecc. Il loro modo di operare è essenzialmente quello della delocalizzazione. Le grandi multinazionali, le grandi corporazioni industriali, i cartelli della droga, i gruppi neoterroristi e le mafie agiscono esattamente allo stesso modo: scelgono i luoghi più adatti alla loro attività e si spostano altrove ogni volta che trovano condizioni migliori.
La modalità di propagazione delle reti è una modalità di propagazione virale, ma anche la logica dirompente dell’universo delle reti è di tipo virale. Il virus elettronico, trasmesso dagli hacker, che infetta una dopo l’altra le reti informatiche, il virus all’opera nella diffusione delle malattie oggi più discusse (AIDS, afta epizootica, mucca pazza), le spore dell’antrace utilizzate come arma batteriologica, le informazioni che portano alla destabilizzazione a catena dei mercati finanziari globali, la predica infuocata che fa il giro del mondo trasmettendosi su Internet, rientrano tutte nello stesso modello paradigmatico.
*
La globalizzazione a cui assistiamo oggi non è quello «Stato universale» che Ernst Jünger credeva si fosse formato dalla fusione progressiva della «stella rossa» e della «stella bianca», cioè dalla fusione tra Oriente e Occidente (22). Con la globalizzazione la Terra tende a unificarsi sotto forma di mercato, cioè sotto l’orizzonte della logica della merce e della ricerca di un aumento permanente dei profitti. Questo avvento di un mercato globale è accompagnato da una trasformazione delle mentalità. L’internalizzazione del modello di mercato conferma, nella mente e nei comportamenti, il primato dei valori di mercato. Il modello antropologico ormai dominante è il modello utilitaristico: l’uomo è definito come un individuo interessato principalmente a produrre e (soprattutto) a consumare, come un agente economico che dovrebbe cercare costantemente di massimizzare il suo miglior profitto. Si passa così da una società col mercato a una società di mercato. Ma va da sé che lo sviluppo del commercio non elimina né l’alienazione né il pregiudizio. Non è stata la sinistra «cosmopolita», va sottolineato, ma la destra liberale ad aver realizzato, o permesso, la globalizzazione. Ciò corrisponde alla tendenza laica del capitalismo: per definizione, il mercato non ha altri limiti che sé stesso. L’osservazione che il capitalismo si è dimostrato più efficace del comunismo nel realizzare l’«ideale internazionalista» è quindi solo apparentemente paradossale. Storicamente, il «cosmopolitismo» si è espresso principalmente a sinistra, ma oggi non è la sinistra, ma al contrario i partiti di destra che promuovono più attivamente la globalizzazione. Chi critica la globalizzazione senza dire alcunché sulla Forma-Capitale, farebbe meglio a tacere. La globalizzazione è prima di tutto il risultato della modernizzazione che si concretizza in piani di adeguamento strutturale volti a integrare tutte le società del pianeta nel mercato globale. È una modernizzazione che si presenta come una risposta alla crisi della modernità conseguente all’Illuminismo (23), ma la risposta che essa fornisce consiste solo nella radicale autonomia dell’economia di mercato, nella finanziarizzazione del capitale e, allo stesso tempo, nell’ascesa della tecnoscienza. L’idea generale è che la scienza ci permetterà di capire tutto, la competenza tecnica di risolvere tutto e il mercato di comprare tutto. Non è così. Karl Polanyi aveva previsto che il mercato avrebbe distrutto la società. Eccoci qui. Il «commercio dolce», che secondo Adam Smith avrebbe dovuto pacificare le relazioni umane, ha trapiantato la guerra all’interno stesso del mercato. La dittatura dell’economia, il primato del settore privato nella conduzione della cosa pubblica, porta allo scioglimento del vincolo sociale. L’universo della deregolamentazione generalizzata porta ad un livellamento al ribasso delle culture, tutte ridotte allo stesso denominatore consumistico. «L’occhio senza pregiudizi», osservava Jünger già quarant’anni fa, «è sorpreso dal vasto, sempre crescente conformismo che gradualmente copre tutti i Paesi – non solamente e non tanto come monopolio dell’una o dell’altra delle potenze in competizione, ma come stile di vita globale» (24). «Lo shock contemporaneo della globalizzazione», scrive oggi Philippe Engelhard, «è la conseguenza di un liberalismo universalista che, nonostante le apparenze, odia le differenze. Il suo programma implicito è quello di un’omogeneizzazione del mondo da parte del mercato e, quindi, dello sradicamento sia dello Stato-nazione che delle culture […] Il completamento della società liberale non sopporta le scorie culturali o comunitarie. Il programma liberale massimalista mira all’eliminazione delle differenze, qualunque sia la loro natura, perché sono un ostacolo al grande mercato e alla pace sociale. Infatti, non è solo la scoria culturale ad essere in eccesso, ma il fatto sociale stesso […] La logica della modernità occidentale risiede fondamentalmente nella non cultura universale del mercato totale» (25).
Ma la globalizzazione non è nemmeno l’universalità. Per certi versi è addirittura il suo contrario. Perché l’unica cosa che universalizza è il mercato, cioè una modalità di scambio economico che rinvia a un momento della storia di una cultura ben precisa. La globalizzazione, come si sta svolgendo oggi davanti ai nostri occhi, rappresenta solo l’imperialismo di un Occidente mercantile, un imperialismo interiorizzato dalle stesse persone che lo subiscono. La globalizzazione è l’imitazione di massa dei comportamenti economici occidentali. È la conversione dell’intero pianeta a questa religione del mercato, i teologi e sommi sacerdoti della quale tengono un discorso dove l’unico fine ultimo è la redditività (26). Non è un universalismo dell’essere, ma un universalismo dell’avere. È l’universalismo astratto di un mondo frammentato, dove gli individui non sono più definiti da altro che non sia la loro capacità di produrre e consumare. Il capitalismo si propone così di riuscire dove il comunismo aveva fallito, senza considerare la giustizia sociale beninteso: creare un pianeta senza confini abitato da un «uomo nuovo». Ma questo uomo nuovo non è più il lavoratore, non è più il cittadino, è il consumatore «connesso», che condivide il destino comune di un’umanità senza differenze collegandosi a Internet o andando al supermercato.
«Lo scrittore portoghese Miguel Torga», ricorda Zaki Laïdi, «un tempo definì l’universale come “il locale senza i muri”. Con ciò intendeva dire che i valori dell’universalità potevano essere promossi e difesi solo se, prima, le persone si fossero sentite radicate in una solida realtà locale. Ora, la globalizzazione sviluppa una dinamica opposta. Gli individui si sentono sradicati a causa della globalizzazione, senza potere sulle cose, e di conseguenza si sforzano di erigere muri, per quanto fragili e irrisori» (27). Sul piano psicologico, così come gli Stati stanno diventando impotenti, gli individui oggi hanno ugualmente la sensazione di essere espropriati di sé stessi da logiche troppo potenti, processi sempre più rapidi, vincoli sempre più ingombranti, variabili così numerose che non riescono più a cogliere il livello rilevante della loro azione. Che questo fenomeno avvenga in un momento in cui l’individuo è sempre più solo, abbandonato a sé stesso, in un momento in cui anche tutte le grandi visioni del mondo sono crollate, non fa che accentuare questa sensazione di vuoto generalizzato. «La globalizzazione», dice ancora molto giustamente Zaki Laïdi, «riproduce stranamente il meccanismo freudiano della folla coinvolta nel movimento contagio-panico. Contagio nella misura in cui la globalizzazione sviluppa conformità e uniformazione; panico perché tutti si sentono soli di fronte a logiche che li superano» (28). La globalizzazione sembra un po’ un puzzle di immagini esplose. Non si lega a nessuna visione del mondo, vieta ogni rappresentazione, mentre le autorità pubbliche, che la dichiarano irreversibile, non hanno esse stesse alcun supporto simbolico da offrire di contro a essa. «La radice del problema della globalizzazione deriva dall’interazione tra un mondo senza confini e un mondo senza punti di riferimento […] È questa dialettica tra un mondo senza confini e un mondo senza punti di riferimento che spiega la crisi di senso e che, allo stesso modo, rafforza la nostra percezione di un mondo disordinato» (29).
Pensiamo alla terribile frase scritta da Péguy nel 1914, poco prima di morire: «Tutti sono infelici nel mondo moderno».
*
Certo, più la globalizzazione si dispiega su scala planetaria, più generalizza una dialettica che ne rappresenta la principale contraddizione. Nella misura in cui la globalizzazione appare, non senza ragione, come l’imposizione unilaterale dello stile di vita occidentale, suscita quasi ovunque forti resistenze «identitarie». Più la globalizzazione attualizza l’uniformazione, maggiormente potenzia la frammentazione; più attualizza il globale, maggiormente potenzia il locale. Da un capo all’altro del pianeta, le società più minacciate dalla globalizzazione cercano di riaffermare il proprio particolarismo, di riconquistare la propria personalità. Ma è qui che hanno le maggiori difficoltà. Alcune inventano identità da zero; altre cercano con tutte le forze di ricreare un’interiorità fittizia in un mondo dove tutto diventa pura esteriorità. Molte adottano forme di azione convulse, alimentate da frustrazioni di ogni genere, che portano irrimediabilmente all’irredentismo e alla xenofobia. Assistiamo quindi a questo scontro che Benjamin R. Barber ha riassunto con la formula «Jihad contro McWorld» (30). Da un lato, un pianeta in via di standardizzazione, via via omogeneizzato dal commercio e dalla comunicazione globale; dall’altro, raggruppati sotto la comoda etichetta della «Jihad» un insieme di tensioni identitarie, aggressive affermazioni etniche o religiose, che generano guerre civili e conflitti tribali un po’ ovunque (31). La globalizzazione, si potrebbe dire, sta distruggendo e resuscitando le identità collettive con lo stesso movimento. Ma quelle che fa riapparire non sono le stesse. La globalizzazione rimuove le identità organiche ed equilibrate e le restituisce in forma puramente reattiva.
Un tale scoppio di identitarismi convulsivi si può certamente comprendere, poiché è solo la conseguenza, tutto sommato logica, della trasformazione dell’intero pianeta in una società che non ha più un esterno: l’eccesso di apertura porta inevitabilmente all’eccesso di chiusura. La ricomparsa di tribalismo, familiarismo, attaccamento al clan o un esacerbato attaccamento alla propria etnia possono quindi essere interpretati come un disperato tentativo di reagire a una minaccia di espropriazione. Tuttavia, non possiamo approvare queste reazioni che, con i loro eccessi troppo frequenti, si screditano da sole.
Sarebbe molto più corretto considerarle, come fa appunto Barber, come facenti coppia con la globalizzazione. Da un lato, queste due tendenze apparentemente antagoniste si giustificano reciprocamente facendo affidamento sui rispettivi eccessi per imporre eccessi nella direzione opposta: l’aggravarsi delle disuguaglianze derivanti dai vincoli dell’economia generalizzata spinge i più poveri all’estremismo, mentre alla fine delle guerre etnico-religiose il dilagare di McWorld riprende con ancora più forza il possesso delle anime. D’altra parte, per molti aspetti costituiscono solo due forme diverse, quella soft e quella hard, dello stesso fenomeno negativo, poiché concorrono a estinguere ogni forma di democrazia e di partecipazione attiva alla vita pubblica da parte dell’insieme dei cittadini. Quindi gli estremi si uniscono. Già nel 1920, anche il linguista russo Nicolas S. Troubetzkoy aveva osservato la relazione paradossale tra cosmopolitismo e sciovinismo. «E’ sufficiente considerare concretamente lo sciovinismo e il cosmopolitismo», scriveva, «per rendersi conto che non c’è alcuna differenza radicale tra i due, infatti sono solo due gradi, due aspetti di un solo e unico fenomeno» (32). Il cosmopolitismo, aggiunge, nega le differenze nazionali solo sulla base di un’idea di umanità riferita a un modello specifico. Invita solamente l’umanità civilizzata a formare un’unica entità universalizzando il modello di una particolare civiltà, in questo caso la civiltà occidentale, implicitamente considerata come lo «stadio» più completo della civiltà tout court. «C’è dunque», conclude, «un parallelismo totale tra sciovinisti e cosmopoliti […] La differenza è semplicemente che lo sciovinista prende in considerazione un gruppo etnico più ristretto di quanto faccia il cosmopolita» (33). Ma entrambi conoscono un solo e medesimo criterio di giudizio: «Ciò che ci somiglia è sempre migliore di ciò che è diverso da noi» (34).
*
Quanto sopra è sufficiente per capire quanto sarebbe inutile cercare di individuare un «direttore d’orchestra» della globalizzazione. Nella misura in cui consiste essenzialmente in una moltiplicazione di reti, la globalizzazione non ha una base, un operatore o un posto di comando centralizzati. La potenza americana, che oggi è il suo vettore principale, in quanto unica grande potenza mondiale, ne rappresenta solo una parte subordinata. Proprio come la finanza o la tecnologia, la globalizzazione opera secondo una propria logica: modello orizzontale, non verticale, «cibernetico» e non azionato o comandato a distanza. La causa dello sviluppo della globalizzazione risiede nella sua stessa esistenza. Il fenomeno della globalizzazione è irreversibile? A lungo termine, nessuna risposta è possibile: per definizione, la storia è sempre aperta. Ma per ora – e molto probabilmente per i decenni a venire – la globalizzazione è chiaramente il quadro della nostra storia attuale.
Da questo punto di vista, dobbiamo stare attenti a non commettere una serie di errori. Uno di questi sarebbe credere che sia ancora possibile sfuggire agli effetti della globalizzazione volgendosi all’interno, chiedendo ilmantenimento delle identità in senso puramente etnocentrico. La «logica del bunker» oggi non è più praticabile, proprio perché siamo in un mondo dove tutto si riverbera su tutto. Perdere interesse per ciò che accade altrove, credere che non ci riguardi, ci impedisce di vedere che invece ci riguarda eccome. Un secondo errore consisterebbe nel porsi in una prospettiva di retroguardia, limitandosi a cercare di rallentare le dinamiche già in atto. I movimenti di destra, da almeno un secolo, hanno fatto delle battaglie perse una loro specialità. Lamentarsi della situazione presente mentre si rimpiange il passato non porta da nessuna parte. Possiamo combattere solo sapendo come è configurato il campo di battaglia oggi – e come sarà configurato domani -, non sognando cosa potrebbe essere o ricordando quello che era una volta. Si tratta di non sbagliare epoca, cioè di essere consapevoli del momento storico che stiamo vivendo. Si tratta di vedere cosa sta arrivando, per determinare cosa sia possibile fare.
Si possono fare altre due importanti osservazioni. La prima è che la natura mondiale della globalizzazione, che è senza dubbio la sua forza, è anche ciò che in qualche modo ne determina la sua debolezza. In un mondo globalizzato, tutto influisce su tutto istantaneamente. Nulla può più fermare la propagazione delle onde d’urto, come vediamo con le grandi crisi finanziarie che, scoppiando in un qualsiasi punto del pianeta creano immediatamente ripercussioni in tutto il mondo. Questa è una fonte di notevole vulnerabilità. La seconda osservazione è che l’estensione delle reti, che costituisce uno dei tratti più caratteristici della globalizzazione, rappresenta anche uno dei mezzi per combatterne gli effetti. Le reti sono un’arma. Permettono ai dissidenti di riunirsi da un capo all’altro del mondo e coordinare la loro azione. È significativo che i movimenti antiglobalizzazione siano essi stessi movimenti globalizzati, come abbiamo visto a Seattle, Genova, Porto Alegre o altrove.
È anche abbastanza chiaro che la crescita incontrollata del capitalismo finanziario non è l’unica via d’uscita dalla crisi che il mondo sta vivendo oggi, e che devono essere sviluppate regole per reagire a tutti i livelli contro le forme che attualmente assume la globalizzazione. Non è impossibile, innanzitutto, tentare di regolamentare i mercati finanziari a livello internazionale. Avanzata originariamente dal professor Tobin, l’idea di imporre una tassa sui movimenti finanziari in valute estere ha già guadagnato terreno. Non è certo una panacea per tutto, tuttavia, una tassa dello 0,05% sulle transazioni globali di valuta estera scoraggerebbe una serie di transazioni speculative a brevissimo termine e frutterebbe proventi pari a 150 miliardi di dollari all’anno, il doppio dell’attuale importo degli aiuti internazionali. Tale somma potrebbe, ad esempio, consentire la creazione di un fondo globale di protezione sociale o di difesa dell’ambiente. Si potrebbero anche immaginare organizzazioni internazionali che gestissero l’economia mondiale in modo diverso da come fanno attualmente, e che avrebbero il compito di imporre la ridistribuzione di una parte sostanziale dei guadagni della globalizzazione a beneficio di coloro che ne sono le principali vittime. Philippe Engelhard propone, da parte sua, la creazione di una moneta globale. Essendo alla base della circolazione finanziaria planetaria il fluttuare delle valute, il ritorno a un loro stabile standard di valore internazionale impedirebbe ovviamente una speculazione che si nutre principalmente di differenze di cambio. Tuttavia, se ammettiamo che «il fenomeno della globalizzazione è visto come la rivincita dell’economico sul sociale e sul politico» (35), è ugualmente ovvio che la risposta alla globalizzazione non può essere solo economica. Si pone allora la questione di saper colmare il divario che vediamo oggi tra la formidabile crescita dell’economia mondiale e il fatto che non abbiamo alcuna forma di organizzazione politica e sociale in grado di arginare questo fenomeno. Se assumiamo come principio che la politica debba controllare e regolare l’economia, potremmo dedurre, dal momento in cui ci troviamo in presenza di un’economia planetaria, che anche politicamente si debba agire a livello globale. In altre parole: una volta che l’economia si è globalizzata, la politica non dovrebbe fare altrettanto? Ma sappiamo bene che uno Stato mondiale è una chimera e che la sua instaurazione, con modalità quantomeno nebulose, solleverebbe ancora più problemi di quanti ne consentirebbe di risolvere (36). D’altro canto, voler contrapporre lo Stato-nazione alla globalizzazione costituirebbe un nuovo errore. Primo, perché la globalizzazione non fa altro che estendere all’intero pianeta un processo di omogeneizzazione che le burocrazie statali hanno già ampiamente svolto in passato a livello nazionale: sta facendo su larga scala ciò che lo Stato-nazione ha già fatto su piccola scala. In secondo luogo, soprattutto, perché lo Stato-nazione costituisce oggi il livello di intervento e di decisione maggiormente paralizzato dalla globalizzazione. Soggetto a vincoli esterni che superano radicalmente le sue capacità (dispiegamento mondiale di poteri economici, trasmissione satellitare di programmi di informazione, commercializzazione globale di nuove tecnologie, gestione dei problemi ecologici, traffico transnazionale, ecc.), lo Stato-nazione non è semplicemente più in grado di affrontare da solo i problemi globali. Far credere che lo Stato nazionale possa ancora decidere sovranamente sull’apertura o chiusura delle sue frontiere ai flussi finanziari; far credere che sia possibile ricostruire una società solidale al riparo di muri che isolerebbero i suoi abitanti dall’esterno del mondo, è solo una visione utopica o una menzogna.
L’ Europa politica e, più in generale, la regionalizzazione di un certo numero di grandi raggruppamenti continentali potrebbero invece costituire un rimedio contro la globalizzazione. Senza essere una garanzia assoluta (perché c’è sempre il rischio che, attraverso gli investimenti diretti, i Paesi interessati si trovino a far fronte alla concorrenza interna di imprese multinazionali esterne alla zona), l’integrazione europea potrebbe consentire di soddisfare le esigenze di mercati sufficientemente ampi costituendo un polo con una dimensione adatta ad affrontare i flussi finanziari globali. L’area economica europea è potenzialmente il primo mercato mondiale in termini di popolazione e livello complessivo di potere d’acquisto. Un’autorità politica europea, che permetta di controllare e coordinare le politiche monetarie e di bilancio, faciliterebbe l’abbandono delle politiche di crescita estroflesse basate su una crescita autoreferenziale, senza rinunciare alla protezione sociale. Allo stesso tempo, la moneta unica (l’Euro) potrebbe essere messa a frutto per ridurre le prerogative del Dollaro, divenendo così un elemento di riconquistato potere e di sovranità. È infatti solo su questa scala che si può sperare di recuperare le possibilità di controllo che gli Stati isolati hanno ovviamente perso. Ma occorre andare verso un’Europa veramente sovrana, dove ogni tappa dell’integrazione dei mercati nazionali sia accompagnata da una superiore capacità di imposizione e di decisione politica, e non verso un’Europa di mercato strutturata come una semplice zona di libero scambio, o verso un’Europa burocratica e accentratrice, basata sull’espropriazione delle autonomie locali. Tuttavia, sappiamo che oggi non è così. Così come sono ora, le istituzioni europee possono essere tanto facilmente un polo di resistenza alla globalizzazione quanto divenirne un vettore. Tutto ciò che per il momento possiamo constatare è che gli atti comunitari vincolanti per gli Stati membri non derivano da alcuna reale sovranità europea (37).
Infine, c’è il livello della vita quotidiana. Rimane il livello locale, che è l’unico in cui gli uomini politici possono ancora vedere gli effetti delle loro azioni. Di fronte alla globalizzazione del commercio, di fronte all’universalizzazione dei segni, di fronte a questa ondata di fondo che cancella tutte le differenze e tutti i valori, resta la singolarità delle forme. Restano le lingue, le culture, resta un legame sociale da ricreare pazientemente nell’esistenza quotidiana. Philippe Engelhard scrive a questo proposito che «la riabilitazione del politico passa, prima o poi, per una ricostruzione del sociale e del culturale, e viceversa. Si deve considerare la cultura non come un dato statico, ma come una tensione creativa, portatrice di senso e di approfondimento dell’arte del vivere insieme» (38). Da parte sua, Jean Baudrillard ha recentemente osservato che «ogni cultura degna di questo nome si perde nell’universale. Ogni cultura che diventa universale perde la sua singolarità e muore. È il caso di quelle che abbiamo distrutto assimilandole con la forza, ma è quello che sta succedendo anche alla nostra cultira con la pretesa di renderla universale». E ha aggiunto: «Tutto ciò per cui si manifesta oggi si manifesta contro l’universale, contro questa universalità astratta» (39).
Per una potenza globale sarebbe perfettamente inutile volersi opporre a un’altra potenza globale. La strategia della rottura consiste, al contrario, nell’opporre il locale al globale, il piccolissimo al grandissimo. Nella postmodernità, i rapporti di forza hanno cambiato natura. Cinquant’anni fa, l’obiettivo di ciascuna potenza era cercare di acquisire risorse altrettanto importanti – e se possibile più importanti – di quelle della potenza avversaria (l’«equilibrio del terrore» dei tempi della Guerra Fredda). Oggi i conflitti si caratterizzano piuttosto per l’asimmetria delle forze presenti, come abbiamo visto ancora una volta, in modo spettacolare, con gli attentati dell’11 Settembre. Il declino degli Stati-nazione sta liberando energia dalla base. Promuove le possibilità di azione locale e, allo stesso tempo, la ricomparsa della dimensione politica del sociale. L’applicazione a tutti i livelli del principio di sussidiarietà, che consiste nel permettere che si elevi solo ciò per cui i livelli inferiori non hanno competenza concreta, sarebbe uno dei modi migliori per porre rimedio all’attuale contenuto della globalizzazione.
Alain de Benoist
Traduzione a cura di Manuel Zanarini
Note:
- Cf. in particolare Robert Reich, L’économie mondialisée, Dunod, 1993 ; François Chesnais, La mondialisation du capital, Syros, 1994 ; Jacques Adda, La mondialisation de l’économie, 2 vol. (1 : Genèse ; 2 : Problèmes), Découverte, 1996 ; Samir Amin, Les défis de la mondialisation, L’Harmattan, 1996 ; Anton Brender, L’impératif de solidarité. La France face à la mondialisation, Découverte, 1996 ; Jean-Yves Carfantan, L’épreuve de la mondialisation. Pour une ambition européenne, Seuil, 1996 ; François Chesnais (éd.), La mondialisation financière. Genèse, coût et enjeux, Syros, 1996 ; Elie Cohen, La tentation hexagonale. La souveraineté à l’épreuve de la mondialisation, Fayard, 1996 ; Philippe Engelhard, L’homme mondial. Les sociétés humaines peuvent-elles survivre ?, Arléa, 1996.
- Principes d’une critique de l’économie politique.
- Op. cit., p. 543.
- « La sequenza degli eventi», diceva Marcel Mauss nel 1920, « va nella direzione di una crescente moltiplicazione di prestiti, scambi, identificazioni anche nei dettagli della vita morale e materiale» (« La nation », in Œuvres. 3 : Cohésion sociale et divisions de la sociologie, Minuit, 1969, p. 625).
- Op. cit., vol. 1.
- Cf. Bertrand Badie, La fin des territoires, Fayard, 1996.
- Cf. Charles-Albert Michalet, Le capitalisme mondial, PUF, 1985.
- « La liberalizzazione dei trasferimenti internazionali di capitali», scrive Samir Amin, «l’adozione di tassi di cambio fluttuanti, gli alti tassi di interesse, il deficit della bilancia dei pagamenti americana, il debito estero del Terzo Mondo, le privatizzazioni, determinano insieme una politica perfettamente razionale che offre a questi capitali fluttuanti lo sbocco di una precipitosa corsa agli investimenti finanziari speculativi, evitando così il pericolo maggiore di una massiccia svalutazione del surplus di questi capitali »(«La vera posta in gioco della globalizzazione » (« Les vrais enjeux de la mondialisation », in Politis-La Revue, octobre-décembre 1996, p. 70).
- Philippe Engelhard osserva a questo proposito che sono «i popoli il cui sistema culturale è stato meno brutalizzato dalla modernità occidentale o che, almeno, si sono aperti ad esso con cautela, [che] sembrano avere le migliori performance economiche. È il caso del Giappone, ma anche di alcuni popoli del Sud-Est asiatico e della Cina”»(op. cit., p.23).
- Suzanne Berger, « Le rôle des Etats dans la globalisation », in Sciences humaines, septembre-octobre 1996, p. 55.
- « Mondialisation et démocratie : un point de vue nord-américain », in Marzo-Aprile1996, p. 16.
- « Internet et tchador, même combat », in La Vie, 14 novembre 1996, p. 58. Cf. Benjamin R. Barber, Djihad versus McWorld, Desclée de Brouwer, 1996.
- Già Marcel Mauss osservava che «un internazionalismo degno di questo nome è l’opposto del cosmopolitismo. Non nega la nazione. La individua. L’inter-nazione è l’opposto di una-nazione sola» (“La nation et l’internationalisme”, testo del 1920, in Œuvres, vol. 3, op. cit., p. 630).
- Le grand transformation, Gallimard, 1983.
- Bertrand Badie, «Mondialisation et société ouverte », in Après-demain, Aprile-Maggio 1996, p. 9.
- Pierre-Noël Giraud, L’inégalité du monde. Economie du monde contemporain, Gallimard-Folio, 1996.
- Ian Robinson, art. cit., p. 19.
- «Seconde jeunesse pour les comptoirs coloniaux », in Le Monde diplomatique, Aprile 1996.
- Op. cit., vol. 1, p. 94.
- Ricardo Petrella, in Le Monde diplomatique, Maggio 1995. Su come la globalizzazione riduca i poteri degli stati nazionali, cf. anche Kenishi Ohmae, The Borderless World, Harper Collins, New York 1990 (trad. fr. : De l’Etat-nation aux Etats-régions, Dunod, 1996) ; Vincent Cable, « The Diminished Nation-State », in Daedalus, printemps 1995 ; Kenishi Ohmae (ed.), The Evolving Global Economy. Making Sense of the New World Order, Harvard University Press, Cambridge 1995.
- « Mondialisation et société ouverte », art. cit., p. 9.
- L’Etat universel, Gallimard, 1962. Jünger ha evocato un’evoluzione che «suggerisce che la differenza tra la stella rossa e la stella bianca sia solo lo sfarfallio che accompagna il sorgere di una stella all’orizzonte. Lascia che salga nel cielo e l’unità si dispieghi» (p. 35).
- Cf. Gustave Massiah, « Quelles réponses à la mondialisation ? », in Après-demain, Aprile-Maggio 1996, p. 6.
- Op. cit., p. 34.
- Op. cit., pp. 199, 250 et 256. Engelhard aggiunge: «Ma poiché le differenze sono inevitabili, quelle della ricchezza, dei talenti o quant’altro, gli individui dovranno diventare assolutamente indifferenziati […] Questa indifferenziazione, che può sembrare per certi aspetti insopportabile, è latente nel paradigma neoclassico che postula l’assoluta separabilità delle funzioni di preferenza dagli agenti. In altre parole, le mie scelte devono essere perfettamente indifferenti da quelle del prossimo, e non confrontabili […] Questa indifferenziazione, che culmina nell’assoluta separabilità delle funzioni preferenziali dagli agenti, è strettamente legata alla negazione del dato culturale. In effetti, qualsiasi appartenenza culturale o comunitaria potrebbe stabilire una connivenza tra le preferenze degli individui del gruppo. Il principio di separabilità verrebbe messo in discussione” (ibid., pp. 251 et 256).
- Cf. à ce sujet Philippe Lançon, « L’économie, comme théologie de la contrition », in Libération, 3 Giugno 1996, p. 5.
- « Qu’est-ce que la mondialisation ? », in Libération, 1er juillet 1996, p. 6. Cf. anche Zaki Laïdi, Un monde privé de sens, Fayard, 1996 ; « Pour une pédagogie de la mondialisation », in Après-demain Aprile-Maggio 1996.